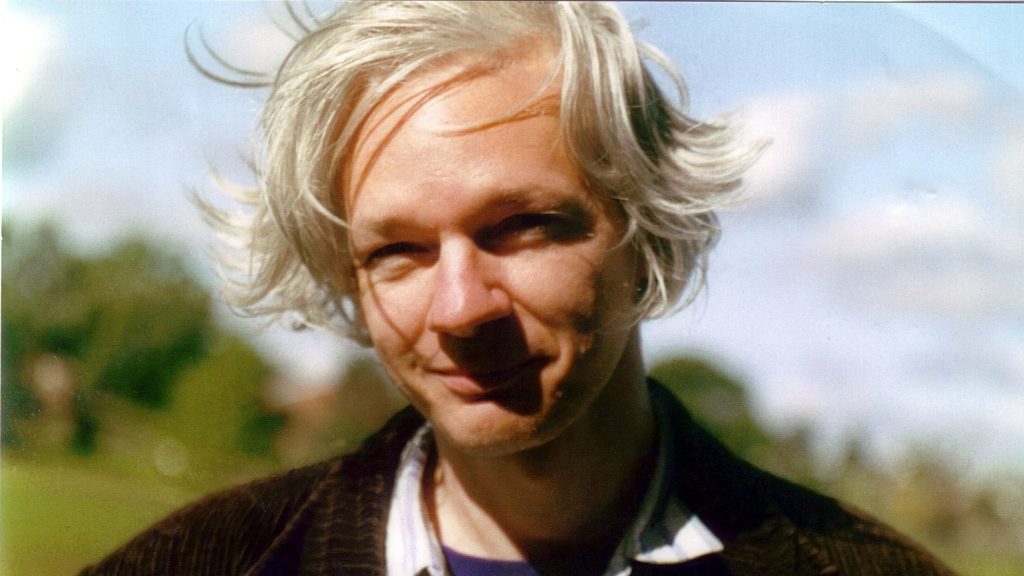Il Giappone di Abe
Che il degrado delle relazioni sinogiapponesi sia stato provocato dalla modifica dei rapporti di forza in corso tra la seconda e la terza potenza economica mondiale è un fatto innegabile.
Coincidenza temporale ha voluto che il primo cedimento grave nelle relazioni si sia verificato in seguito a un drammatico incidente marittimo verificatosi nel 2010, anno in cui la Repubblica popolare scala la classifica delle economie mondiali e sottrae al Giappone il secondo posto. La Cina economica, militare e diplomatica sopravanza oggi un Giappone strutturalmente indebolito dalle difficoltà economiche, dal declino demografico
e dalla catastrofe nucleare del 2011. Una sovrapposizione di problemi che danneggia il prestigio e l’influenza internazionale del paese. Il mandato forte dato a Shinzo Abe e al Partito liberaldemocratico dall’elettorato giapponese (che gli ha assicurato la maggioranza nelle due camere del Parlamento) incoraggia oggi il primo ministro a esercitare una politica più assertiva e decisa, che egli stesso definisce il “ritorno del Giappone” sulla scena globale.
Ecco allora l’Abenomics, una politica economica che come primo atto ha approvato uno stimolo fiscale da 10.000 miliardi di yen (oltre 70 miliardi di euro) mentre promette radicali quanto inediti e controversi interventi strutturali di stampo liberista che dovrebbero tirare il paese fuori dalle secche di una stagnazione economica in corso ormai da vent’anni. Ma l’ambizione del premier, che già nel 2007 era stato costretto a dimettersi anzitempo, è più vasta e per certi aspetti allarmante, tanto da far parlare di un Abe neoconservatore e ultranazionalista, decisamente in marcia verso destra.
Parte integrante della concezione del premier è una visione strategica indirizzata a rilanciare il ruolo giapponese nella regione asiatica a fronte degli sconvolgimenti indotti dall’ascesa cinese e dalla politica di “ribilanciamento” verso l’Asia, il cosiddetto “pivot”, dell’amministrazione Obama. È in quest’ottica che Abe sostiene apertamente la necessità di una modifica della Costituzione pacifista giapponese che impedisce ogni proiezione verso l’esterno, quella che per i vertici giapponesi sarebbe invece la possibilità di una “difesa collettiva” da eventuali aggressioni, della quale Tokyo intenderebbe farsi carico (cioè avere la possibilità, oggi negata, di combattere al di fuori dei confini nazionali ben oltre le missioni di pace già operanti) sia pure insieme agli alleati americani. [8]
Abe non perde occasione per esprimere un’insofferenza crescente verso la condizione di tutela militare alla quale il paese è inchiodato da regole concepite quando era il cattivo della storia, sconfitto sonoramente (e in modo devastante) dalla guerra. [9] Emerge con sempre maggiore forza l’aspirazione a essere un paese normale, secondo gli standard di normalità propri di un mondo che cambia pelle, spesso in modo violento. E la posta in gioco più alta è il possesso ufficiale dell’arma nucleare, anche se per ora è un’aspirazione mantenuta in sordina.
Per modificare la costituzione è necessario l’assenso dei due terzi del Parlamento, e non sarà facile averlo a causa della forte resistenza che ancora oggi la società giapponese oppone. Lo dimostra la battaglia, ancora in corso, degli abitanti di Okinawa contro le basi militari americane sull’isola, che ha costretto il governo a negoziare con Washington un ridimensionamento dagli esiti ancora non chiari, vista la nuova fase. Durante un incontro a Tokyo con il premier Abe, avvenuto il 2-3 dicembre del 2013, il vice presidente Usa Joe Biden ha di nuovo fatto pressioni per una nuova base aerea a Okinawa, vista la necessità di chiudere e ricollocare la controversa base di Futenma dove stazionano i marines Usa.
Alle pressioni americane Abe ha risposto con una panoplia di bastoni e carote per convincere il governatore di Okinawa, Hirokazu Nakaima, ad approvare l’inizio dei lavori per la nuova installazione militare. Ma un sondaggio sulla popolazione della prefettura di Okinawa, condotto dal quotidiano giapponese “The Asahí Shímbun” e pubblicato il 17 dicembre 2013, ha rivelato che solo il 22% vuole che il governatore approvi, mentre il 64% vorrebbe che si opponesse un rifiuto. [10]
L’inflessibilità della posizione degli abitanti dell’isola è stata poi confermata nel gennaio del 2014 dalla rielezione a sindaco della città di Nago, l’area prescelta per la nuova base, di Susumu Inamine, fiero oppositore dell’installazione militare. In attesa di avere il Parlamento dalla sua, il governo Abe si attrezza. Nel dicembre 2013 le camere hanno approvato il primo documento di strategia per la difesa nazionale dove si stabilisce che, dopo dodici anni di declino, le spese militari nel 2014 torneranno ad aumentare costantemente e per tutto l’arco dei prossimi cinque anni, fino a un totale di 240 miliardi di dollari (con un aumento di circa 10 miliardi di dollari rispetto al quinquennio precedente).
Nella strategia si argomenta che il Giappone deve dare “un contributo più attivo alla pace” e quando si delinea un avversario il dito si appunta chiaramente contro i tentativi della Cina “di modificare lo status quo con la forza”. Il documento conferma il mantenimento di stretti legami militari con gli Stati Uniti ma sottolinea la necessità per il Giappone “di rafforzare prima e soprattutto le proprie capacità” per far progredire i propri interessi nazionali vista “la rapida ascesa cinese”. [11]
Dall’insieme, emerge un evidente spostamento verso un teatro di guerra marittimo e aereo che induce a domandarsi che cosa sia rimasto dell’articolo 9 della Costituzione. [12] Come se non bastasse, adducendo a ragione la minaccia del nucleare nord coreano, definita “più grave e imminente”, non pochi parlamentari giapponesi chiedono che il Giappone si doti di una strategia di “primo colpo” preventivo. Il documento non la menziona, ma la questione resta sospesa. [13]
Prima ancora che fosse presentato il piano strategico, era stata approvata la creazione, fortemente voluta da Abe, di un Consiglio per la sicurezza nazionale sul modello americano che risponde direttamente al premier e l’inasprimento delle pene per chi divulga segreti di stato e informazioni secretate riguardanti la politica militare ed estera del governo. Una State Secret Law assai controversa e impopolare la cui approvazione ha fatto calare per la prima volta al di sotto del 50% il consenso al governo.
In un tale contesto, la visita al tempio Yasukuni (questa pure, secondo i sondaggi, poco gradita alla maggioranza dei giapponesi) è sulla lunghezza d’onda delle dichiarazioni nelle quali, in diverse occasioni, il premier ha messo in questione il ruolo di “aggressore” del Giappone nel secondo conflitto mondiale e le scuse ufficiali alle vittime di guerra. Ed è ancora Abe che perora la causa di una “educazione patriottica” sostenuta dal governo e rilanciata dal documento sulla strategia di sicurezza nel quale si chiede di coltivare l'”amore per la patria”.
Già il Libro bianco sulla difesa, pubblicato da Tokyo nel luglio 2013, aveva tratteggiato le linee essenziali della nuova fase e indicato nella difesa territoriale contro le attività militari cinesi la ragione chiave per una revisione della strategia e delle spese per armamenti. Sempre in questo documento si dava poi priorità all'”indipendenza” piuttosto che “alla pace e alla sicurezza”, diversamente dai precedenti Libri bianchi. Ma l’aspetto più preoccupante, come notano alcuni analisti, è che un documento ufficiale di questa portata strategica si concentri solo sulle attività militari dell’avversario e sulle contromisure per contrastarlo, senza riservare neppure un cenno a eventuali soluzioni multilaterali e a un dialogo diplomatico.
Il messaggio che tutte le posizioni ufficiali giapponesi inviano in questo momento è dunque che Tokyo risolverà le tensioni crescenti con la Cina solo per via militare e farà di tutto per dotarsi degli strumenti necessari. [14] La strategia di Tokyo tuttavia non solo aumenta gli arsenali ma affina anche le proprie armi economiche e diplomatiche per acquisire un ruolo egemone nei confronti dei vicini asiatici, preoccupati dal montare delle tensioni ai loro confini. Il 13 e 14 dicembre del 2013 Tokyo ha ospitato un incontro dei leader dell’Asean nel corso del quale Shinzo Abe ha agitato la “minaccia cinese”, incorporata in un documento congiunto finale che ha espresso preoccupazione per “la sicurezza marittima, la libertà di navigazione, i commerci senza restrizioni, l’esercizio dell’autocontenimento e la soluzione delle dispute con mezzi pacifici”.
Per rendere più convincente l’azione giapponese, Abe si è impegnato a sborsare 19,5 miliardi di dollari in aiuti allo sviluppo nei prossimi cinque anni. L’offensiva del premier si è spinta anche più in là, con l’incoraggiamento alle compagnie giapponesi a guardare oltre la Cina per i loro affari. Di fatto, nei primi nove mesi del 2013, gli investimenti nipponici nella Repubblica popolare sono caduti a 6,6 miliardi di dollari, dai 13,48 miliardi del 2012. Contemporaneamente quelli nelle quattro maggiori economie del sud est asiatico – Indonesia, Malesia, Thailandia e Filippine – sono cresciuti del 120%, arrivando a circa 7,9 miliardi, con interessanti differenze.
Il Vietnam, per esempio, nel 2013 ha percepito 4,5 miliardi di dollari di investimenti giapponesi, quando nel 2010 riceveva appena 169 milioni. Va certo tenuto conto, in questo consistente spostamento, anche il mutamento strutturale di alcuni elementi fondamentali dell’economia cinese, dal cambiamento demografico del mercato del lavoro all’aumento dei salari, oltre che un generale rallentamento della crescita. Ma l’azione di Abe è ben attenta a inserirsi abilmente anche in altre situazioni, per esempio nelle brecce aperte dalla transizione politica in corso in Birmania. Ai generali riformisti Tokyo ha cancellato un debito di 5 miliardi di dollari e ha assicurato prestiti per la costruzione di nuove infrastrutture, oltre ad annunciare 3 miliardi di dollari di aiuti per le minoranze birmane oppresse.
Alla fine di dicembre 2013, la Marina giapponese ha poi condotto esercizi navali congiunti con le forze indiane, nella baia del Bengala, le prime al largo delle coste dell’India dopo un esordio nel 2012 in acque giapponesi. Una “proiezione di potere”, come si dice in gergo strategico, destinata a far innervosire molto Pechino. [15]
Shinzo Abe ha anche elaborato un’architettura di sicurezza “a diamante”, che include Australia, India, Giappone e Hawaii, volta alla protezione delle vie d’acqua nel Pacifico, per la quale è necessario l’esercizio della difesa collettiva da parte di Tokyo. L’instancabile attivismo del premier ha inoltre aperto altri terreni di sfida contro Pechino. Come quello di una “nuova diplomazia” incardinata intorno a cinque principi, i più spinosi dei quali per la Cina sono la promozione dei diritti universali (democrazia e diritti umani) e il rispetto del diritto internazionale, con la concezione di una difesa egualitaria dell’ordine regionale. [16]
La dichiarata promozione dei diritti universali, in particolare, ha toccato uno dei nervi cinesi più scoperti. Come è ben evidenziato da una serie di editoriali del “Global Times”, organo ufficiale tra i più assertivi. Uno di questi, nel ricordare che centoventi anni fa scoppiava la guerra sinogiapponese, prevedeva che una “guerra calda fra le due nazioni probabilmente sarà evitata” ma osservava anche che una “guerra dell’opinione pubblica” è già iniziata e il suo esito “avrà grande importanza per le strategie delle due parti”. Al centro di questa nuova guerra c’è il tentativo giapponese “di ristabilire un’alleanza con l’Occidente ispirata dai valori, per riguadagnare l’iniziativa”. Ma i “valori”, incalza il quotidiano cinese, sono la “tribuna favorita del Giappone per imbrogliare”. Infatti tale paese “cerca in tutti i modi di dipingere i contrasti con la Cina come sforzi per combattere contro un paese autoritario”. Conclusione: “Non volano proiettili nel campo di battaglia dell’opinione pubblica, ma per vincere questa guerra c’è bisogno che l’intera società cinese resti unita”. [17]
La Cina di Xi Jinping
Con l’ascesa di Xi Jinping al vertice della leadership cinese, anche la Cina sembra aver imboccato la strada dell’uomo forte al potere. Più disinvolto, meno imbalsamato del suo predecessore Hu Jintao, Xi ha preso possesso in modo irruento e deciso delle leve di un potere immenso, la segreteria del Pcc, la presidenza dello stato e il comando della Commissione militare centrale, ottenuto da subito, diversamente dal suo predecessore che dovette aspettare due anni prima di installarsi a capo delle forze armate. Il neosegretario ha imposto immediatamente il suo slogan del “sogno cinese”, impastato di nuova potenza per il paese e di benessere per i cinesi. Ha lanciato una campagna dura e a tutto campo contro i corrotti, “mosche o tigri” che fossero, e su questa scia ha imposto uno stile più sobrio ai costumi del partito.
La campagna anticorruzione ha preso di mira teste eccellenti, molte delle quali appartenenti a una fazione politica che il capo dei capi ha tutto l’interesse a combattere, vale a dire ciò che resta dei vecchi alleati di Bo Xilai. Lo si è capito quando nel mirino degli inquirenti sono entrati Zhou Yongkang, il potente ex capo della sicurezza interna e grande protettore dell’ex segretario del partito in Chongqing, e una serie di manager delle grandi imprese di stato a lui legati.
L’impronta forte di Xi Jinping e la sua presa decisa sul potere sono state confermate dagli esiti del Terzo Plenum del novembre 2013. Dalla riunione plenaria del Comitato centrale, tradizionalmente dedicata all’economia, la leadership è uscita con un piano di riforme a medio/lungo termine che affronta tutti i problemi economici, sociali e ambientali più gravi generati dai precedenti dieci anni di corsa economica e ormai veri e propri nodi scorsoi intorno al collo del paese. Con in più un evidente cambio di passo, politico e ideologico, considerata l’affermazione che ha imposto i titoli dei giornali sul Plenum, quella nuova priorità assegnata al ruolo del mercato che da “basilare” è diventato “fondamentale”. [18]
Piani vasti e ambiziosi di riforme strutturali che richiedono di mettere mano all’intero sistema. Una missione ad alto rischio e necessaria da tempo, che ha visto la leadership precedente fallire su tutti i fronti. Xi Jinping non vuole fare la stessa fine, anche perché stavolta la sconfitta costerebbe caro. Di qui la decisione di dotarsi di nuove armi. Dal Plenum sono così usciti due nuovi organismi, un Comitato per la sicurezza nazionale, cui spettano decisioni “rapide ed efficienti” in materia di sicurezza interna e internazionale, e un gruppo centrale ristretto di guida del partito con l’incarico di redigere, organizzare e far applicare i piani di riforma. Entrambi rispondono direttamente ai vertici e rivelano la volontà dell’attuale leadership, in primis Xi, di avere il pieno controllo della situazione e di poter tagliare rapidamente i nodi. A queste entità se ne sono aggiunte nei mesi seguenti altre due, che riguardano settori cruciali: una commissione per la cybersicurezza e un gruppo ristretto per la riforma della difesa nazionale e delle forze armate. Anch’esse risponderanno a Xi Jinping.
Si delinea così una fase in cui più mercato e più autoritarismo saranno le due facce di un’unica moneta, come ben spiegato in un editoriale del “Global Times” che definisce l’era Xi quella del neoautoritarismo 2.0 (laddove la fase di apertura delle riforme era stata governata dall’autoritarismo 1.0 di Deng). Per creare “un’economia di mercato matura e completa”, ciò che l’attuale leadership “dovrebbe fare e sta facendo”, è necessario “il pugno di ferro”. Vale a dire, scrive l’autorevole organo del Pcc, che “Xi deve rafforzare il suo predominio ideologico e la forza del suo discorso contenendo un’esplosione di partecipazione politica, perché questa non va bene per la stabilità”.
Con una dose massiccia di riforme neoautoritarie, assicura il quotidiano, “la maggior parte dei problemi sociali sarà eliminata, i pensieri estremi pro sinistra e pro destra saranno marginalizzati e il popolo cinese sarà concorde nel riconoscere che il paese governato dal partito conseguirà prosperità e democrazia. A quel punto potremo parlare di democrazia in senso proprio”. [19]
L’insieme appena descritto conferma la crescita della statura politica e del ruolo di Xi Jinping e rende ancora più chiaro che i nuovi organismi costituiscono un unicum nel quale si intrecciano e confluiscono la dimensione interna e quella internazionale, a conferma che la politica estera in Cina, più che in ogni altro paese, è funzionale a un equilibrio interno che per essere mantenuto ha bisogno di aumento della ricchezza economica, sicurezza dell’approvvigionamento di risorse, crescita del prestigio globale della “nazione cinese”. E soprattutto della convinzione che solo il Partito comunista può assicurare tutto questo.
A ulteriore conferma dell’intreccio: da almeno tre anni la spesa militare viene superata da quella per la sicurezza interna, circa 121 miliardi di dollari nel 2013. Le ultime cifre, fornite in occasione della riunione del Congresso popolare nazionale, equivalente cinese del Parlamento che si tiene ogni anno a marzo, annunciano che le spese militari nel 2014 aumenteranno del 12,2%, arrivando a 132 miliardi di dollari, mentre nessuna informazione è stata quest’anno fornita riguardo agli stanziamenti per la sicurezza interna.
La Repubblica popolare cinese, che ormai ha raggiunto il secondo posto mondiale quanto a spese militari, al passo con la sua dimensione economica, ha avviato un processo di modernizzazione del proprio esercito che si è tradotto nell’ultimo decennio in un aumento costante e ingente degli stanziamenti (tra il 12 e il 15% l’anno). Se all’inizio del millennio la Cina spendeva la metà del Giappone, nel 2004 ha cominciato a superarlo e oggi è arrivata, secondo dati ufficiali che vengono spesso considerati al di sotto della realtà, a oltre il doppio del vicino/avversario (anche se è ancora ben lontana dalle vette Usa che, pure in ritirata quanto a spese per armamenti, veleggia ancora intorno ai 630 miliardi di dollari).
Quale politica estera aspettarsi da un Pcc che serra i ranghi, centralizza il potere e teorizza una nuova fase autoritaria? Il timore diffuso è che, soprattutto dopo l’inasprimento delle posizioni sulle dispute territoriali, si aprirà una fase diplomatica bellicosa, dalle dinamiche imprevedibili, e ancora più scabrosa di quella fase aggressiva lamentata a partire dal 2009. Prima di quel fatidico anno, tra il 2006 e il 2008, Pechino aveva partecipato in modo più attivo alla gestione di alcuni dossier internazionali spinosi, dalla Corea del Nord al Sudan alla pirateria somala.
L’irruzione della crisi economica globale ha buttato all’aria tutti i fronti. Secondo gli occidentali, la Cina si è sentita più sicura nel fronteggiare la recessione globale, che nell’immediato non solo l’aveva appena sfiorata ma le aveva anche consentito di rafforzare la propria statura globale, forte del fatto di essere l’unico paese ad avere a disposizione una montagna di liquidità. Da qui l’avvio di una strategia da nuova potenza che vede un’offensiva di hard power intrecciarsi con una strategia di soft power. Quest’ultima, lanciata a partire dalle Olimpiadi del 2008, ha visto Pechino investire in un solo anno 4 miliardi di dollari in un piano di miglioramento della propria comunicazione a livello planetario.
Vista dalla Cina, la storia è però speculare. Nel 2010 avviene il primo grave incidente marittimo con il Giappone, una collisione in mare tra un vascello guardacoste nipponico e un peschereccio cinese seguita dall’arresto del capitano di quest’ultimo. In quello stesso anno, l’amministrazione Obama decide che è arrivato il momento di ritirarsi dai disastrati teatri di guerra mediorientali e di tornare a occuparsi di Asia. Si delinea la strategia del “pivot”, un riequilibro militare ed economico per rafforzare la presa degli Stati Uniti (“nazione del Pacifico”, asserirà Obama) sulla regione asiatica.
La lettura universale, negata da Washington, è che ciò avvenga in una strategia di contenimento della Cina. A ogni modo, l’esordio di Barack Obama non piace a Pechino. Dopo che nel 2009 i due paesi hanno solennemente assicurato l’uno all’altro di rispettare i reciproci “interessi vitali”, nel 2010 la Repubblica popolare vede il Congresso Usa dare il via alla vendita di nuovi armamenti a Taiwan, un’ondata di critiche contro l’inasprimento della censura su internet e un incontro privato tra Obama e il Dalai Lama (che si è ripetuto nel 2014).
Nel frattempo continua, e si inasprisce, la querelle contro lo yuan sottovalutato e le politiche commerciali scorrette cinesi. In un susseguirsi di alti e bassi, si arriva ai giorni nostri. L’inaspettata introduzione di una zona di controllo aereo è sembrata contraddire le prime mosse in politica estera della leadership di Xi, volte a rassicurare i paesi Asean. Nell’ottobre 2013, sia Xi sia il premier Li Keqiang si erano impegnati in un’offensiva diplomatica in grande stile, presenziando sia al vertice Apec (Asia Pacific Economic Cooperation) sia all’East Asia Summit. Una partecipazione da star, grazie all’assenza di Barack Obama, costretto a cancellare il viaggio in Asia per l’esplosione della crisi dello shutdown in patria.
Un vuoto di enorme valore simbolico nel momento in cui Xi Jinping si impegnava a portare a 1000 miliardi di dollari entro il 2020 l’interscambio commerciale fra Pechino e l’Asean, assicurava di voler discutere insieme alle dieci nazioni dell’organizzazione di un codice di condotta vincolante per risolvere le dispute nel Mar cinese meridionale e sottoscriveva intese economiche per miliardi di dollari.
Con il senno di poi, l’offensiva diplomatica può essere letta come un preludio alla successiva mossa contro il Giappone, per disattivare almeno qualcuna delle tensioni di un fronte multiplo e contrastare apertamente la parallela offensiva giapponese descritta sopra. Ma la decisione sull’Adiz rimanda a uno scenario anche temporalmente più vasto. Quello delineato dal Libro bianco cinese sulla difesa pubblicato nel 2013 e da altri documenti ufficiali che, ricordando come sia ancora valida la valutazione che sostiene alcuni principi guida strategici, e cioè che la Cina fino al 2020 può giovarsi di un “periodo di opportunità strategiche”, rileva che questo arco di tempo favorevole è oggi “sottoposto a tensioni senza precedenti” a causa della strategia americana. [20]
È in questo scenario che vanno inquadrati i discorsi nei quali Xi Jinping, rivolgendosi all’Esercito popolare di liberazione (Pla), ha più volte esortato i militari a essere pronti “a combattere e vincere le guerre”. Mentre dal Terzo Plenum sono emerse indicazioni che i vertici hanno in serbo anche per i militari vaste riforme strutturali per aumentarne l’efficienza e la forza. Tutto indica che, in questo simile al vicino e avversario Giappone, la leadership cinese è convinta che il rischio di conflitto nella regione stia aumentando e si prepari a fronteggiarlo solo militarmente, privilegiando la potenza militare a una strategia diplomatica che impedisca l’escalation e porti a una soluzione negoziata delle dispute.
A completamento del quadro militare, prevalente in questo momento, c’è poi chi sottolinea il valore strategico chiave delle isole Diaoyu/Senkaku in quanto porta d’accesso allo stretto di Miyako, negli ultimi tre anni attraversato sempre più spesso dalla Marina militare cinese per condurre esercizi navali e aerei nel Pacifico occidentale, nell’area compresa fra quelle che vengono definite in gergo strategico la prima e seconda catena di isole, cioè fra la linea che a ovest include l’arcipelago giapponese, Taiwan, Filippine e il Borneo e quella che a est unisce le isole Bonins, le Marianne, Guam (territorio Usa) e l’arcipelago delle Palau.
È qui che entra in gioco la strategia cinese denominata A2/Ad (anti access/area denial) il cui obiettivo finale è la capacità da parte delle forze cinesi di bloccare sin dalla seconda linea di isole ogni attacco aereo e navale esterno, che tradotto in pratica significa contrastare la “libertà di navigazione” e “la libertà dei cieli” rivendicata oggi dagli Stati Uniti per intervenire nel mar della Cina meridionale e orientale e a Taiwan nelle condizioni previste dai trattati di mutua difesa sottoscritti con i paesi dell’area.
La teoria degli strateghi viene testata con sempre maggior frequenza in quelli che prima o poi potrebbero diventare veri e propri teatri di guerra. Alla fine di ottobre 2013 la Marina e l’Aviazione cinesi hanno effettuato una manovra militare nel Pacifico occidentale oltre la prima catena di isole, riunendo navi da guerra e bombardieri e annunciando trionfalmente alla fine di aver “smembrato” il blocco.
Il Giappone ha risposto subito al colpo e a novembre ha allestito diciotto giorni di gigantesche manovre terrestri, navali e aeree, le più grandi dalla fine della seconda guerra mondiale, che hanno riunito 34.000 soldati, sei navi da guerra e 340 aerei. Per la prima volta, le forze di autodifesa nipponiche hanno puntato i missili terra-nave Type 88 verso lo stretto di Miyako. A questo punto molti cominciano a chiedersi se Xi Jinping non stia archiviando definitivamente i famosi principi di Deng Xiaoping che hanno finora imposto un basso profilo alla politica estera del paese, in particolare con la raccomandazione di “nascondere le proprie abilità e attendere il proprio momento”.
Se Hu Jintao aveva cominciato a sottrarsi più e meno armoniosamente al “basso profilo”, secondo alcuni Xi Jinping avrebbe scelto una rottura chiara davanti alla crescente instabilità della regione causata, secondo Pechino, dalla strategia americana di intervento in Asia. In questo senso va l’opinione di un autorevole consigliere del governo, Yan Xuetong, preside dell’Istituto per le relazioni internazionali dell’università Tsinghua, che in un articolo sul sito Guancha, tradotto in parte e pubblicato dall'”Huffington Post”, partendo dall’assunto che l’inevitabile ascesa della Cina la ponga in rotta di collisione con gli Usa, nota come Xi Jinping stia articolando una diversa direzione strategica.
Per più di vent’anni, rileva l’accademico, la Cina ha operato in un quadro geopolitico in cui non aveva né amici né nemici, allo scopo di mantenere condizioni internazionali favorevoli allo sviluppo economico, una “suprema priorità”. “Questa posizione” scrive Yan “non è più mantenibile. Sotto Xi la Cina comincerà a trattare amici e nemici in maniera differente”. La Cina farà sì che coloro “che vorranno avere un ruolo costruttivo nell’avanzata cinese” ottengano “i più grandi vantaggi dal suo sviluppo”. In futuro, spiega ancora lo studioso, “la Cina favorirà decisamente coloro che saranno al suo fianco con benefici economici e anche protezione militare. Al contrario, chi sarà ostile dovrà affrontare politiche molto più pronunciate di sanzioni e isolamento”. [21]
Gli sviluppi futuri diranno se l’analisi di Yan Xuetong corrisponde a quel che si muove dietro le mura di Zhongnanhai, la cittadella del potere cinese. Quel che è certo è che la Cina ha, dal dicembre scorso, una ragione in più per interrogarsi su quel che le accade intorno e prendere nuove misure. I rapporti complicati e contraddittori con la Corea del Nord sono sfociati in un’epurazione brutale che ha visto in quattro giorni arrestare platealmente in diretta televisiva e mettere a morte Jang Sungthaek, zio del giovane leader Kim Jong-un, numero due del regime, già consigliere ascoltato del padre Kim Jong-il e, dalla morte improvvisa due anni fa di questi, mentore del ventenne figlio.
Nell’opacità delle notizie arrivate da Pyongyang, una delle accuse rivolte a Jang ha fatto interpretare la mossa brutale come un gesto diretto contro la Cina, alla quale lo zio, molto filo Pechino e fautore di grandi riforme economiche sul modello cinese, avrebbe venduto a prezzi stracciati le risorse del paese, carbone, minerali, terre rare. Tanto che qualche opinionista cinese si è spinto fino ad accusare senza mezzi termini il giovane leader di voler “de-sinificare” la Corea del Nord per avvicinarsi agli Stati Uniti. [22]
Nelle prime ore successive all’epurazione era arrivata anche la notizia che Jang Sung-thaek era stato accusato di stare addirittura preparando in combutta con Pechino un golpe per cacciare Kim Jong-un. La notizia non è stata in seguito confermata, ma l’esecuzione di uno degli interlocutori più vicini ai cinesi all’interno della corte nord coreana non promette nulla di buono per i vertici cinesi, e conferma la preoccupante irrequietezza dell’area.
NOTE
- [8] Andrew L. Oros, Does Abe’s Rightward Shift Threaten His Legacy?, PacNet n. 2, Pacific Forum Csis, 7 gennaio 2014.
- [9] Si veda l’intervista rilasciata alla rivista del Council on Foreign Affairs Usa: Japan is Back. A conversation with Shinzo Abe, “Foreign Affairs”, July-August 2013.
- [10] Japan-China-Usa relations reach new lows while arms budget grows.
- [11] Oltre a un aumento consistente di cacciatorpediniere (da quarantasette a cinquantaquattro), sottomarini (da sedici a ventidue), caccia a reazione (venti aerei in più che porteranno il totale della flotta a duecentottanta) e l’introduzione di droni nelle forze aeree, l’esercito giapponese costituirà un proprio corpo anfibio, simile ai marines Usa, chiaramente funzionale a operazioni di sbarco dal mare e alla riconquista di un territorio remoto (si legga Senkaku-Diaoyu). Tecnica d’assalto finora pressoché ignorata dalle forze giapponesi.
- [12] L’articolo 9 della Costituzione giapponese stabilisce che: “Aspirando sinceramente a una pace internazionale basata sulla giustizia e l’ordine, il popolo giapponese rinuncia per sempre alla guerra come diritto sovrano della nazione e alla minaccia e all’uso della forza come mezzo per dirimere le dispute internazionali. Per realizzare lo scopo, le forze di terra, mare e aria, come ogni altro potenziale di guerra, non saranno mai tenute. Il diritto di belligeranza dello stato non sarà riconosciuto”. La norma fondamentale giapponese dunque proibisce non solo l’uso della forza per dirimere i conflitti ma anche il mantenimento di forze armate. Per cui, in termini strettamente legali, le cosiddette forze di autodifesa dovrebbero essere un’estensione della polizia nazionale.
- [13] Island Defence. Self Defence Can Look Menacing, 21 dicembre 2013.
- [14] Toshiya Takahashi, Japan’s 2013 defence white paper stirs tensions with China, 31 luglio 2013.
- [15] Sol W. Sanders, In East Asia, Japan Is on the Move… Away from “Rising China”, 6 gennaio 2014.
- [16] Antonin Francesch, Les Actions du Japon pour la création d’une architecture régionale de securité en Asie-Pacifique, in “Japan Analysis La lettre du Japon”, 31 ottobre 2013, Asia Centre.
- [17] Japan Casts Dark Spell on Public Opinion, “Global Times”, 7 gennaio 2014.
- [18] Per un approfondimento sul Plenum, si veda l’articolo su Globalproject.
- [19] “Iron Fist” at Top Needed to Ensure Proper Democracy, “Global Times”, 9 gennaio 2014.
- [20] Si veda China’s Air Defense Identification Zone: Impact on Regional Security” di Nicholas Szechenyi, Victor Cha, Bonnie S. Glaser, Michael J. Green, Christopher K. Johnson, “Csis Asia Team”, 26 novembre 2013.
- [21] Yan Xuetong, China’s New Foreign Policy: Not Conflict But Convergence of Interests, 28 gennaio 2014.
- [22] Da Zhigang, Purge May Mean Pyongyang’s Swerve away from Beijing, 6 gennaio 2014.
Continua
GLI ARTICOLI PRECEDENTI
Questo testo è il capitolo “Il triangolo fatale delle Diaoyu/Senkaku. La Cina avanza, il Giappone declina, gli Usa riscoprono l’Asia… e la contesa sulle isole precipita” scritto dalla giornalista ed esperta di Asia Angela Pascucci per il libro Wars on demand – Guerre nel terzo millennio e lotte per la libertà. Il volume è stato curato Vicenza libera dalle servitù militari ed è stato pubblicato dalla casa editrice Agenzia X nella collana Global Books. Tutto il libro è rilascio con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate.