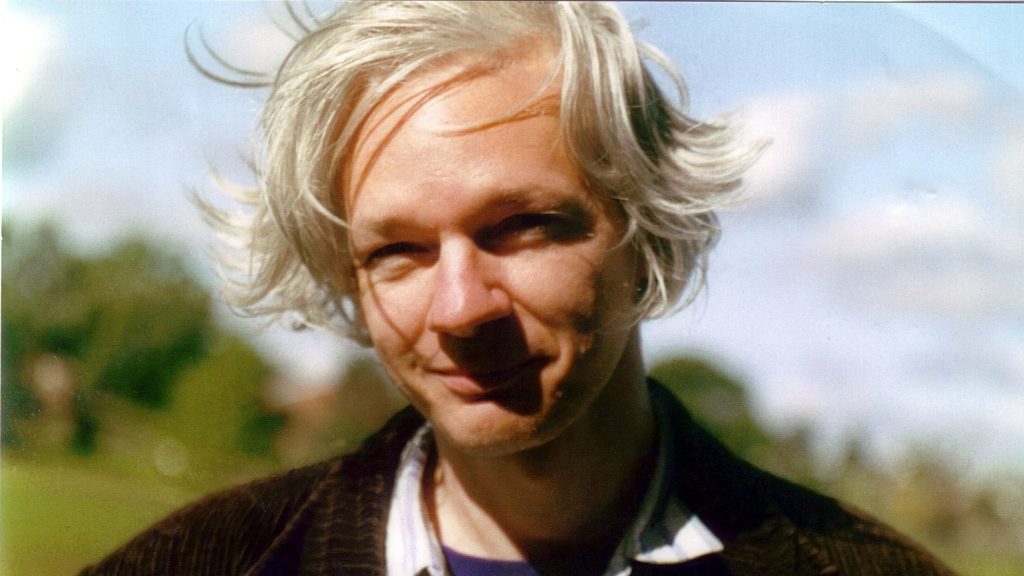di Angela Pascucci
Mai risolta, la disputa fra Cina e Giappone sulle isole Diaoyu/Senkako nel mar della Cina orientale si riaccende periodicamente, ogni volta più infiammata a causa delle crescenti rigidità e intransigenze dei contendenti. Stavolta il gong del nuovo round è stato suonato dalla Cina quando, il 23 novembre scorso, ha annunciato l’istituzione di una nuova zona di difesa del proprio spazio aereo (Adiz, Air Defence Identification Zone), che include le isole contese e si sovrappone alla zona di controllo giapponese e, sia pur in misura minore, quella sud coreana. Con questa decisione Pechino impone a chiunque sorvoli l’area di identificarsi e fornire i propri piani di volo all’aviazione cinese, che in caso di inadempienza attuerà “misure difensive di emergenza”.
Ne è seguita una serie di scaramucce a jet sfoderati, aperta dagli indimenticabili B52 americani, due esemplari dei quali, decollati da Guam, sono stati spediti subito da Washington con un duplice scopo: far capire da che parte della contesa si colloca, in nome dei trattati di sicurezza sottoscritti con Tokyo, e sfidare la reazione cinese, che in questo caso si è limitata a “sorvegliare” l’azione (dichiarando che il sorvolo americano è avvenuto ai limiti dell’area).
Attraverso la breccia aperta dagli Usa (che formalmente hanno dichiarato trattarsi di “regolari esercizi” da loro normalmente condotti nell’area) si sono precipitati poi i jet militari giapponesi e anche quelli sud coreani. La Cina ha deciso in tutti questi casi di far decollare a mo’ di controllo un paio di velivoli della propria contraerea ma non ha ancora agito per imporre il rispetto delle nuove regole di identificazione, platealmente e volontariamente violate (anche se gli Usa hanno consigliato alle loro compagnie aeree civili di ottemperare alle richieste cinesi). Una reazione che ha sollevato un putiferio tra i frequentatori dei social network come Weibo, la versione cinese di twitter, che hanno chiesto in massa intransigenza fino alla guerra.
Finora l’incidente fatale è stato evitato ma si preannuncia un periodo in cui le scaramucce, talvolta rischiose, già in corso sul mare che circonda le isole, saranno replicate anche sui cieli, dove il gioco si fa più pericoloso. Solo Taiwan (che in continuità con la storia della Repubblica popolare porta avanti in modo autonomo le stesse rivendicazioni ma col Giappone dialoga) è rimasta a guardare, con grande preoccupazione.
In tutto questo intrico, è palese che la decisione della Rpc ha aperto un capitolo nuovo, ancor più gravido di incognite e pericoli, in un conflitto che si placherà solo quando nell’area del Pacifico occidentale si saranno stati stabiliti nuovi equilibri geopolitici, dopo che quelli vecchi sono stati buttati all’aria dall’ascesa della potenza cinese.
La situazione è ora in uno stato di sospensione ma l’atteggiamento di intransigenza che ormai prevale sembra un punto di non ritorno. Come è stato possibile che la seconda e la terza economia mondiali, arrivate ad accumulare uno scambio commerciale che ormai ammonta a oltre 330 miliardi di dollari, siano giunte a tanto? Alla considerazione che i soli rapporti economici non bastano a ripianare controversie e odi storici va aggiunta quella che l’economia può costituire, e ciò è evidente nel caso sino-giapponese, un elemento di frizione forte quando le traiettorie si incrociano perché una sale e l’altra scende. E il Giappone sta affrontando il suo declino davanti alla Cina con un mix pericoloso di timore per il futuro e di sfida, che lo spinge a mettere alla prova limiti e capacità del vicino e avversario, convinto che cedere equivarrebbe a mostrare debolezza. Da parte sua, anche Pechino sta testando la propria forza e capacità di egemonizzare la regione.
Troppo lungo sarebbe qui ripercorrere tutta la complessa storia delle isole Diaoyu/Senkaku e delle rivendicazioni che le riguardano. Le sue radici lontane si ritrovano alla fine dell’800, quando lo storico conflitto sino-giapponese si intreccia con l’interventismo delle potenze occidentali; si propagano fino al II conflitto mondiale e al suo epilogo; attraversano pressoché silenti i decenni che chiudono il XX secolo e riaffiorano come frutti avvelenati nel secondo decennio del terzo millennio. Nel 1972, gli Stati uniti riconsegnano Okinawa alla sovranità giapponese e con l’arcipelago anche le Senkaku/Diaoyu, delle quali tuttavia affidano a Tokyo solo l’amministrazione, riconoscendo in tal modo l’esistenza di una controversia (secondo alcuni mossa maligna perché foriera di conflitto). Di fatto, negli anni ’70, prima Zhou Enlai e poi Deng Xiaoping intrattengono con il Giappone colloqui che sfociano in un tacito accordo (mai sottoscritto formalmente e oggi negato da Tokyo) di accantonare la questione per non compromettere la normalizzazione dei rapporti, nella speranza che il futuro porti la saggezza necessaria a una soluzione. (Chi è interessato a una ricostruzione più approfondita della disputa può leggere Gavan McCormack, “Much Ado over Small Islands: The Sino-Japanese Confrontation over Senkaku/Diaoyu” in The Asia-Pacific Journal, Vol 11, Issue 21, No. 3, May 27, 2013).
L’andamento del conflitto su quei cinque scogli sperduti e deserti ha assunto nel corso del tempo un valore simbolico tale da rispecchiare le differenti fasi storiche attraversate da Cina e Giappone nel corso del loro turbolento ‘900, con un’intensità rafforzata nel 1968 quando un rapporto aggiunge a quello simbolico anche un valore assai materiale, facendo balenare la prospettiva che i mari intorno alle isole possano celare “uno degli ultimi, più ricchi, inesplorati giacimenti di olio e gas naturale” esistenti al mondo che solo chi ha la sovranità su quegli scogli potrà sfruttare appieno. Una ricchezza enorme che tuttavia resta ancora da accertare, anche perché richiederebbe la collaborazione pacifica degli interessati. Di fatto il litigio è rimasto silente per lungo tempo, salvo qualche esplosione di rivendicazione isolata, e senza conseguenze incendiarie, da parte di gruppi nazionalisti delle due parti, anche grazie al tacito accordo dei governi di non fomentarli. Ancora nel 2008 il premier giapponese Yasuo Fukuda e il presidente cinese Hu Jintao durante un loro incontro dichiarano il proprio impegno a fare del Mar della Cina orientale “un mare di pace, cooperazione e amicizia” e a tale fine si firma un’intesa per lo sfruttamento comune degli idrocarburi nel mar della Cina orientale. L’ impegno è reiterato un anno e mezzo dopo da un altro premier nipponico, Yukio Hatoyama. Tre mesi dopo, il leader del trionfante Partito democratico, Ichiro Ozawa, guidava una delegazione di 600 persone in missione semi ufficiale di amicizia a Pechino.
La distensione termina bruscamente nel 2010, con l’arresto del capitano di un peschereccio cinese che navigava nelle acque contese e la dichiarazione del governo giapponese, ancora guidato dal Partito democratico già in crisi, che le isole fanno parte integrante del territorio nipponico e non c’è nulla da discutere.
Da allora, l’escalation è stata continua e inarrestabile. Il culmine viene toccato nel 2012 quando la decisione del governo giapponese di “nazionalizzare” tre isole acquistandole dal proprietario giapponese provoca un’ondata di manifestazioni violente nella Repubblica popolare, che inducono i giapponesi a chiudere, sia pure per breve tempo, le loro fabbriche e i negozi delle loro catene commerciali sul continente, a causa delle violente proteste cinesi.
Nel dicembre 2012 è tornato al governo in Giappone il Partito liberal democratico con il nazionalista e conservatore Shinzo Abe, a novembre una nuova leadership guidata da Xi Jinping si è installata a Pechino. Un cambiamento di teste che sembra aver rinfocolato, in modo nuovo e per nulla rassicurante, tutta la controversia, come se la questione fosse usata dai rispettivi leader in funzione interna, per rafforzarsi con il cemento nazionalista, che fa sempre presa. E non è peregrino ipotizzare che Xi Jinping voglia con la nuova assertività bilanciare il new deal di riforme “di mercato” decise dal recente Terzo Plenum del Partito.
In Giappone, la posizione di intransigenza sulle isole viene rafforzata da un governo di destra che ha riacceso con il suo negazionismo tutti i punti di conflitto storico con la Cina ed è determinato a procedere con la modifica della Costituzione pacifista che non consente ora al paese di andare oltre l’auto difesa e di intervenire oltre i propri confini. (Si veda l’intervista a Shinzo Abe “Japan is Back” in Foreign Affairs July/August 2013).
Sullo sfondo, ma ben presente, il convitato di pietra americano. Vi sono studiosi che rilevano come l’ingombrante presenza sia attiva da oltre un secolo e ricordano gli sforzi della diplomazia americana alla fine dell’800 per impedire che il trattato sino-giapponese del 1871 si trasformasse in un’alleanza dei paesi dell’Asia orientale contro l’Occidente, prospettiva vista come “una calamità” dai diplomatici americani che nel 1879 spingono il Giappone a impadronirsi del reame di Ryukyu (tributario dell’impero cinese e del quale le isole contese facevano parte) e trasformarlo in un suo dipartimento. (Philippe Pelletier, Le chien et l’elephant. Le Japon au miroir de la Chine, in Hérodote, 3e trimestre 2013,”Regards geopolitique sur la Chine”)
L’impressione che l’oggi rimanda è che il divide et impera americano sia ancora all’opera e che gli Usa abbiano bisogno del conflitto sino-giapponese per continuare ad affermarsi come i garanti della stabilità nell’area. Anche in quest’ottica va vista la strategia del “pivot” elaborata dall’amministrazione Obama che teorizza il ritorno del protagonismo americano in Asia e che la Cina percepisce, non a torto, come una strategia volta al suo contenimento. (Strategia, sia detto qui come cenno ma meriterebbe approfondimento, che favorisce enormemente l’industria bellica americana. Si veda in proposito http://www.reuters.com/article/2013/01/01/us-usa-asia-arms-sales-idUSBRE90005D20130101).
Di fatto, il presente vede il Giappone sempre più integrato in un sistema di difesa avanzato controllato da Washington, al quale Pechino risponde con una strategia di riarmo e un sistema di difesa volti a depotenziarlo.
Il segretario della difesa americano Chuck Hagel ha definito l’azione cinese “un tentativo destabilizzante per alterare lo status quo nella regione”. Visto dalla Cina, è esattamente l’opposto. E’ stata l’assertività giapponese a cambiare lo status quo e la decisione di Pechino sull’Adiz ne è la risposta speculare. E se il Global Times, quotidiano ufficiale a forti tinte nazionaliste, richiama scenari da nuova Guerra Fredda e scrive a chiare lettere che la Cina non tornerà indietro perché “siamo pronti a impegnarci in uno scontro prolungato col Giappone. Il nostro scopo ultimo è sconfiggere la sua volontà di potenza e ambizione a istigare un conflitto strategico contro la Cina” (“Japan prime target of ADIZ tussle” 29/11/2013, htttp://www.globaltimes.cn/content/828546.shtml#.UpjqvrmA3cs) , voci più ragionevoli ma non meno autorevoli spiegavano, prima dello scoppio della crisi, che l’obiettivo cinese “è arrivare a una giurisdizione e a un pattugliamento congiunti nelle acque in questione per negare al Giappone il controllo unilaterale delle isole. Pechino vuole costringere il Giappone a modificare la sua posizione di ‘nessuna disputa territoriale'” (Ren Xiao, direttore del Centro Studi della Politica estera cinese, Diaoyu/Senkaku disputes — a view from China.)
Per la Repubblica popolare non c’è in ballo solo la contesa con Tokyo ma anche la soluzione di tutte le dispute aperte nel Mar Cinese meridionale, dove lo scontro più forte è con il Vietnam e le Filippine. L’esito che avrà il conflitto a nord, non potrà non influenzare quello in atto a sud.
Con il braccio di ferro in corso le Diaoyu/Senkaku assurgono di nuovo a simbolo dell’oggi e c’è chi teme che possano assumere il ruolo di una Sarajevo del XXI secolo. Tokyo ha annunciato che alla fine dell’anno diffonderà le nuove linee guida di difesa nelle quali verrà probabilmente articolata una nuova politica che vedrà i cieli e i mari delle Senkaku pattugliati costantemente e non in modo intermittente, come ora. Un baratro potrebbe aprirsi nel Mar della Cina, che inghiottirebbe vincitori e vinti.
Questo articolo è stato pubblicato da Global Project il 2 dicembre 2013