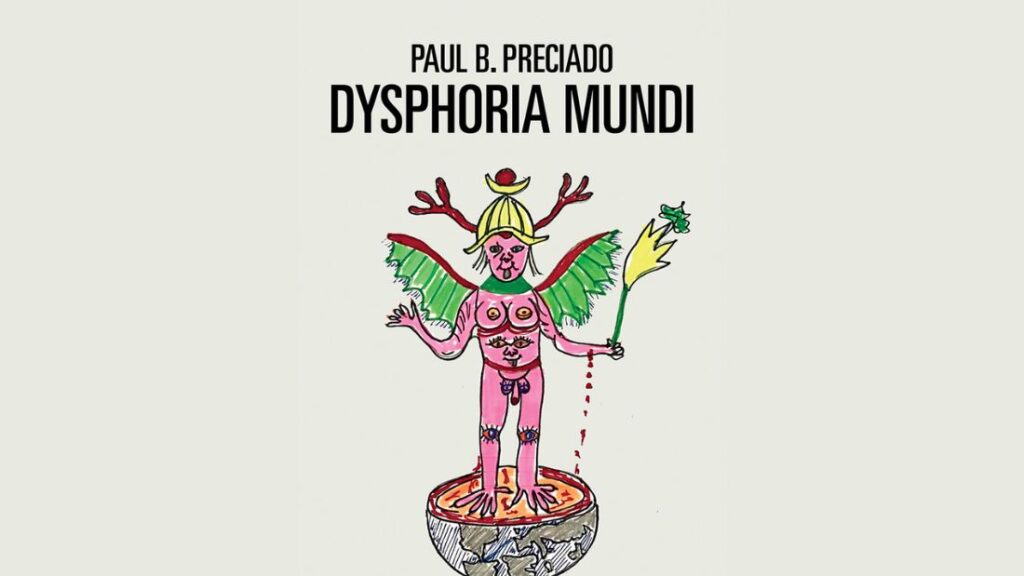Ed ecco due libri nella valigia estiva, che in verità, al di là degli aspetti sentimentali, non sono propriamente leggeri e da collocarsi nella categoria… di stagione.
Anzi, direi la loro prerogativa accomunante essere la disarmante schiettezza della vena autobiografica sapientemente rimaneggiata e quell’inafferrabile sentimento di melanconia per tutte le cose che, se non sono finite neppure sono andate come si voleva e si sono trasformate sotto i nostri occhi in un modo che non abbiamo saputo prevedere o controllare e financo comprendere fino in fondo.
Ma andiamo con ordine. Da un lato gli Anni forti di Paola Martini, ragazza degli anni ’70, di area pisana, oggi insegnante di lettere con molte passioni e una precedente raccolta di racconti all’attivo, per Manni Edizioni e dall’altro, per i tipi di Incipit 23, questo Volevamo conquistare il Cielo scritto in tandem da Donatella di Paolo e Laurenzo Ticca, entrambi giornalisti professionisti democratici approdati curiosamente a Mediaset in qualità di conduttori e redattori di telegiornali qui alle prese con una storia d’amore e molto altro che si snoda a Milano dal 1969 in avanti fino ai 90.
Sgomberiamo il campo da un’idea. Ovvero che in qualche modo questi due libri siano sovrapponibili, magari banalmente a partire proprio dalla cronologia.
Ebbene no e in questa considerazione si apre potenzialmente, al di là dei due lavori in oggetto, una possibile riflessione su quanto oggi per noi nel contemporaneo, riferendosi a quel periodo la, quello delle contestazioni, quello degli anni 70, quello degli anni di piombo e del sei politico, (sto volutamente abborracciando insieme una quantità di luoghi comuni,) ci sia di risonante e intrigante. Come per esempio potrebbe essere l’emergere, l’affermarsi e il sedimentarsi di un mondo relazionale differente e di una ancora di là da venire, pallidissima postura di convergenze tra questioni trasversali alla classe.
Perché intendo dire che entrambi i testi, pur fermandosi molto prima degli anni 2000 nella loro narrazione ed anche questo mi sembra un dato molto significativo in maniera differente per ciascuno, evidentemente esondano dal loro stesso recinto e biografico e storico per ritornare più o meno consapevolmente là dove c’è l’irrisolto delle passioni talvolta tristi, talvolta spente, talvolta ancora brucianti nell’attualità e di più, nella quotidianità. Ovvero dove la scelta individuale spesso sembra cozzare con l’ideale collettivo, dove la tempra personale, la misura etica di ognuno di noi viene testata e messa alla prova.
Se ci pensate bene, la dialettica individuo-collettività, è il nostro decumano mentale ed emotivo, che percorriamo sì disinvoltamente perché la razionalità geometrica, l’esprit de claritè che lo governa lo consente, ma senza spesso riuscire ad inserirvi profittevolmente quelle deviazioni, quei trabocchetti, quegli infiniti hic rodus, hic salta, di cui le nostre individuali esistenze son costituite. Ben oltre i diktat di qualche assemblea o comitato centrale o comitato comunque dovunque collocato nella galassia del nostro scontento.
In questo senso, dunque, bisogna sottolineare quanto in modalità e proporzioni diverse i due romanzi biotopici siano positivamente segnati da una ispirazione di genere che non vorrei definire relazionale per non doverla banalizzare secondo un certo afflato mainstream. Pubblica voce secondo la quale naturalmente i rapporti e gli affetti siano temi donneschi e tutto il resto appartenga comunque ad un logos universalisticamente attingibile, pur tuttavia superiore intellettualmente secondo canoni patriarcalmente consolidati. Canoni ascrivibili, comunque, ad un percorso e patrimonio storico, pur sempre tale perché generalisticamente riconosciuto e dunque, che piaccia o meno, fruibile, persino nelle condizioni di Cenerentola, che comunque in qualche modo, raccoglierà i ceci in tempo per il ballo e pazienza se comunque non avrà contribuito alla sua organizzazione.
Ma noi smaliziati lettori tra le pagine chiare e le pagine scure sappiamo bene che i saperi relazionali, nel senso di quelli capacitanti alle connessioni, sono oggi quelli più importanti anche in senso propriamente scientifico, che la lezione della capacità dal basso di autolettura dei bisogni, di autoanalisi e introspezione, di autocura tramite supporto tra pari, fossero pure gli anelli più deboli nella catena sociale sono forse gli unici veri strumenti a disposizione per il cambiamento in senso trasformativo che ci sono rimasti dal tramonto coattato delle ideologie. E guarda caso, sono leve in mano alle donne e a tutte le minoranze e le divergenze e i generi e le culture colonizzate e non comprese nel grande calderone del discorso pubblico.
Perché non basta dichiararsi universalisti, se il nostro universo conosciuto è molto ristretto, razzializzato, antropologicamente connotato in un senso unico, comunitario magari anche, ma nell’accezione di una perimetrazione che esclude l’alterità.
In un mondo interiorizzato segnato dal perseguire le affinità elettive ad ogni costo, neanche fossero il Santo Graal, quanto posto ci può essere davvero per l’accoglienza dell’altro, del diverso da noi, nonostante tutto il nostro convincimento di essere open-minded?
Questi due libri, che forse potremmo definire di autofiction o di biografia romanzata, in qualche modo sono uno stress test rispetto a tutto questo? Ci consentono insieme all’adesione affettiva, biografico compatibile, o alle trepidazioni di svolgimento narrativo, di sviluppare ragionamenti non solo letterari, artistici ma anche più ampi, per esempio anche rispetto alla struttura di classe in cui all’epoca i movimenti studenteschi volevano inserirsi? Un concetto, quello di Classe, di cui peraltro ci sentiamo orfani e che andrebbe riletto e ridefinito a maggior ragione oggi probabilmente proprio a partire da quanto già allora dato per scontato e compreso, si rivelò in realtà essere una galassia di sentimenti ed esistenzialismi a parte tutt’altro che sussunti e pienamente inglobati.
Paola Martini, classe 1951, in buona sostanza dedica il suo memoir ad una generazione di suoi coetanei che non ebbero affatto la sensazione di vivere in anni di piombo, bensì in anni di grande emancipazione personale e straordinaria sperimentazione collettiva.
Una emancipazione nel suo caso difficile per motivi tutto sommato opposti a quelli che la resero operazione ostica ai più. Ovvero un oikos letteralmente avvolgente quale villa Gina, costruzione in pietra di vaga ascendenza napoleonica, casa -mondo, casa rifugio, casa ventre immerso nella campagna toscana profonda insieme alle braccia, allo sguardo empatico e alla governance domestica di Tata, una figura femminile quasi fiabesca che sopravanza nel ricordo persino la madre biologica della protagonista. Un mondo certo non privo di ruvidità e forme di autoritarismo, ma scevro nel racconto dalla ferocia di classe di un Novecento di Bertolucci perché soprattutto i rapporti appunto di classe che vengono agiti qui sono di tutt’altra pasta.
Un’Italia forse un po’ conservativa nella sua lentezza di ritmi, consuetudinarietà, aderenza alle leggi di natura, ma anche positivisticamente e positivamente aderente a valori sani e progressivi, ad una applicazione di principi di uguaglianza che discendono da un’idea di adattamenti opportuni alla vita, quelli per cui l’impegno va da sé, è dovere di ognuno, ma il lavoro di squadra è più proficuo.
Si respira un’aria da piccole Donne dentro questa prima parte del libro, giacché effettivamente, Gli anni forti nasce come progetto di prolungamento di un racconto lungo che Martini aveva dedicato alla sua infanzia incantata, a cui poi ha voluto aggiungere la parte autoformativa della giovinezza universitaria.
Il titolo è bellissimo indubbiamente ed è di per sé una dichiarazione d’intenti cui accennavamo sopra. Sono anni di grande possibilità, nonostante o secondo alcuni forse proprio a causa dei nuovi assetti geopolitici bipolari, in cui il mondo occidentale a partire dal primo dopoguerra vive la stagione gloriosa del welfare e l’Italia, di più, pur tra molte contraddizioni e pesanti processi di modernizzazione di cui vate inascoltato sarà Pasolini, si prova in una sorta di onda lunga di secondo Risorgimento, certo bruscamente interrotto da terrorismi di varia natura e trame stragiste ad oggi non del tutto chiarite. Ma quella stagione di riforme fondative di un senso democratico profondo ci fu e non fu semplicemente una stagione di ribellismo in cui soggettività nuove spintonavano per prendere parola sulla scena pubblica, ma è un po’ come se Martini ci volesse dire che nonostante tanti traumi, trasmissione di esperienza tutto sommato ci fu, che una borghesia di sani principi esisteva in qualche modo ed essa stessa contribuì a formare quella meglio gioventù di buona volontà che raccoglieva più assennatamente di quanto si volle rappresentare il meglio di diverse eredità di pensiero nazional popolare. Non per caso, dunque, il vero momento traumatico nella storia, dopo la morte per droga del compagno di scuola hippy, è dato da una maternità non voluta e dal fortunoso ricorso all’interruzione di gravidanza. il proletariato propriamente detto si materializza nelle pagine durante gli gli attacchinaggi, nei confronti sapidi e vivaci con gli adulti, gli anziani, delle Case del Popolo, che un manipolo di studenti universitari e medi di cui la nostra protagonista fa parte e legato al gruppo eretico, guarda un po’ del Manifesto, ostinatamente persegue. Ma, se volessimo provare appunto a definire i contorni cultural valoriali in cui si inscrive l’esperienza più intima di quella gioventù così peculiare storicamente, collegata ancora inconsapevolmente a tutto il mondo che stava diventando piccolissimo, dovremmo vederli tutti dentro la grande civiltà contadina e il mondo delle competenze professionali.
In qualche modo per quei ragazzi che poterono ancora usufruire, per la prima volta maschi e femmine in modo massivo del famoso ascensore sociale, la fabbrica tanto discussa e vagheggiata è comunque uno sfondo, una conditio sine qua non di discorso per i più politicizzati, ma non esperienza di vita diretta e infine neppure fattore culturale, mi viene anche da dire e per due ragioni, nel caso femminile. Una legata appunto, all’idea di compattezza maschia e forse ancora un po’ misogina che l’universo operaio si porta dietro e l’altra al fatto che questa cultura che pure ci fu a mio avviso e che seppe per alcuni anni esprimere valori complessivi innovativi oltre le rivendicazioni viene sempre letta come appendice delle vicende politiche e partitiche di volta in volta sovietiche, principalmente o anche nelle varianti terzomondiste e più estreme, cubane e cinesi.
Mentre comunque in qualche modo nonostante tutto, forse per l’attitudine pedagogica nel senso migliore del termine dell’autrice, comunque questo libro, scritto con limpidezza e vivacità e un continuo dichiarato riferirsi a capolavori della narrativa nostrana e non solo, (memorabile la descrizione di un bucato a mano con bollitura che a me ha ricordato Zola), si chiude con un invito all’assertività, al provarci, a guardare un domani che da qualche parte ci sarà, non altrettanto si può dire riguardo la chiusa della prova a quattro mani di Ticca e Di Paolo, per lunghi anni colleghi e sodali nel difficile mondo del giornalismo televisivo ed ora buoni compagni di scrittura. E questo in barba alla grande quasi eroica prova di resilienza sotto ogni punto di vista che tocca a quella che nei fatti svetta protagonista del racconto, questa indimenticabile Lea, in parte quintessenza del sogno maschile dei compagni con l’eskimo di quegli anni, tante volte incontrata nei vagheggiamenti ideali di memoirs da loro scritti. Una figura nouvelle vague che esprime il fascino acerbo di nuovi canoni femminili che si affermano, a prezzo, come il libro in parte autobiografico anche in questo caso ci mostra, di grandi drammatiche fatiche emotive delle dirette interessate costrette loro malgrado ieri come oggi a combattere una sorta di nemico all’interno del proprio stesso universo affettivo.
Anche in questo romanzo ci sono i turni per i piatti da lavare, ci sono gli amici e le amiche comprimarie, le mille casette in affitto tutte scomodamente intercambiabili, le mille estenuanti riunioni in cui impossibilitati a sciogliere problemi di linea politica e divisione sotterranea di valori e presupposti, ciò che rimane è più che altro il valore socializzante delle pratiche. Anche in questo caso la fabbrica appare lontanissima e la classe che ci viene invece sciorinata e descritta in tutte le sue possibili sfumature di grigio dal piccolissimo al medio alto, con tutti i suoi limiti e meschinità è la borghesia. La Borghesia che nelle sue varianti anche liberal, progressiste o persino un po’ radicali, rimane comunque timorosa dei bordi estremi e che pure ha dentro di sé e si esprimono con una valenza decadente e distruttiva che forse è la differenza più marcata con il paesaggio emotivo dell’altro libro. Del resto in qualche misura il titolo stesso, Volevamo Conquistare il Cielo, con quel che di prometeico, l’allusione ad un possibile peccato di superbia luciferina, ci indirizza verso un bilancio se non fallimentare comunque di incompiutezza.
Anche qui abbiamo una interruzione di gravidanza come spartiacque però, fatto paradigmatico, detonatore in qualche modo di una tragedia emotiva che avrà conseguenze nelle vite dei due studenti, Luca e Lea, appunto, poi aspiranti giornalisti. Il privato è più che politico in questo libro e in qualche modo questo assolutismo di visione che rende tutta la seconda parte, dopo l’ariosità e la naïveté giovanili, un interno borghese soffocante e concentrazionario, che sia caserma, studio televisivo, redazione di giornale di partito, negozio del centro, studio medico e naturalmente casa coniugale, una sorta di predizione autoavverante dei nostri attuali giorni dello scontento in cui le questioni di genere e anche quelle dell’ascensore sociale sembrano essere del tutto irrisolte o essersi beffardamente tramutate in qualcosa di distopico. A questo proposito dovremo chiedere agli autori se una qualche velata forma di rimpianto o pentimento o senso di colpa anche generazionale alligni in qualche maniera dentro di loro. Certo è che carriera, o meglio percorso personale di crescita, romanzo di formazione o deformazione a seconda dei punti di vista e prospettiva critica di contesto, magari collettiva o sindacalizzata, coerenza tra bisogni e scelte, attivismo o peggio militanza vengono praticamente visti come percorsi e processi nettamente distinti e separati nne fasi della vita. Mai accostabili, insomma. I protagonisti che narrano con sapiente taglio drammaturgico a due voci, lo srotolarsi delle loro vite in una alternanza che avvince il lettore, ci appaiono titanicamente soli davanti alle loro responsabilità. nel caso di Luca, ai propri complessi di inferiorità, alla propria codardia, alla propria irresolutezza che da desiderio di possesso si tramuta in un lasciarsi vivere addosso le cose, nel caso di Lea che comunque ne esce nonostante l’asperità delle prove decisamente meglio, un desiderio di tenere tutto insieme e avere tutto ciò che di materiale e immateriale si può avere nella vita, evidentemente vissuto come peccato di eccesso.
Questa eccedenza del femminile fa sì che i temi affrontati nel libro e tutti collegati ad un discorso di autodeterminazione biopolitica che forse valeva la pena di sondare di più oltre i confini della pur legittima ambizione personale, siano molteplici e tutti sul tappeto: non solo l’interruzione di gravidanza come nodo e diritto sempre in discussione, ma il mobbing, il rapporto gerarchico di poteri non esplicitato ma che mette sempre le donne un gradino sotto, le une contro le altre, la violenza psicologica e fisica, una libertà di scelta anche sessuale che potrebbe essere anche considerata terapeutica in certi momenti esistenziali di ognuno di noi che viene invece appellata e vissuta come tradimento e processo di degradazione fino ad arrivare alla malattia che rappresenta nella narrazione complessiva l’ennesima sconfitta nella governance della propria esistenza. Le figure maschili in qualche modo, dialettizzandosi tra idealizzazione romantica e paternalismo buono e competente, passando per la perversità capricciosa del potere e del denaro (come non pensare a certe personalità giornalistico comunicative di area Mediaset che certo i capaci autori devono aver conosciuto?), non sembrano godere ottima forma psicologica e sicuramente appaiono incapaci ad approcciarsi all’altra metà del Cielo. Il libro su cui molto viene da interrogarsi dopo averlo letto d’un fiato, nonostante approcci tutti da discutere ha indubbiamente da un lato il merito se vogliamo pop di riportare l’ossessione amorosa che si sa, ha sempre come archetipo alterne fortune, al centro della scena, ma anche una riflessione più complessa di quanto sembri, sul fatto che quei temi scivolosi che la cronaca e l’esperienza di tanti ci consegnano hanno origine da o finiscono per provocare faglie interne a noi che sono prevaricazione, sudditanza, derive sadomasochiste, vanità e per questo ci isolano e ci rendono difficile l’affondo politico su di essi.
In tutto questo, io coltivo a questo punto grandi speranze in tutta l’epopea del Collettivo di fabbrica Gkn, che proprio sul tema dell’approccio culturale e intersezionale sta segnando proprio da quella ormai nicchia operaia così messa agli angoli in tutti i sensi, una grande operazione realmente e positivamente titanica di rilettura e rilancio. Una ricerca di egemonia per questo, per altro, per tutto, che sta timidamente cominciando a proporre forme anche femminili di cronaca emotiva, oltreché spettacoli teatrali co costruiti e che si avvale di un utensile prezioso quale il festival di letteratura working class per riaffermare una possibilità altra oltre le confessioni e i tormenti delle anime individuali.