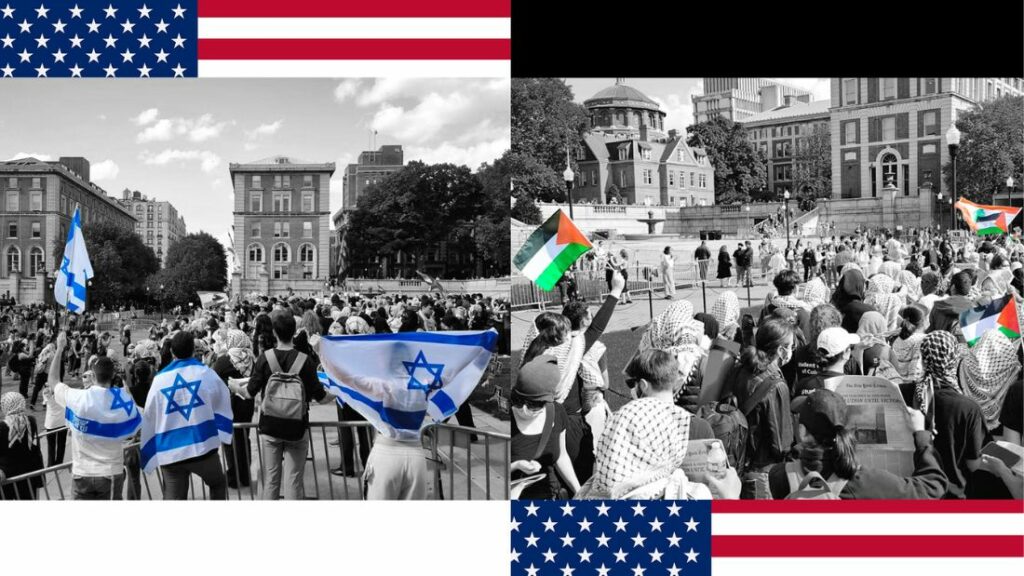Il 25 giugno di quarant’anni fa moriva Michel Foucault. Nello stesso anno, il 1984, veniva pubblicato un saggio che per certi versi può essere considerato il suo testamento: Che cos’è l’Illuminismo?. Vi ritroviamo i tre nodi attorno a cui ruota tutta la riflessione foucaultiana: sapere, potere, soggetto. L’intreccio di questi tre nodi potrebbe riassumersi così: il soggetto è dipendente da forme di sapere, che hanno su di lui effetti di potere, ed è costantemente immerso in relazioni di potere, che producono un determinato tipo di sapere. Ogni soggetto è dunque sempre invischiato in una rete di sapere-potere che ne plasma la mentalità e i comportamenti. Come allora districarsi da questa rete così diffusa, capillare, invasiva?
Il saggio si confronta con questa domanda – che è poi la questione foucaultiana par excellence – passando attraverso Kant. Si tratta dell’estratto di una lezione tenuta da Foucault al Collège de France nel 1983 e pubblicato per la prima volta in inglese nel 1984 col titolo What is enlightenment? Tradotto in italiano col nome Che cos’è l’Illuminismo?, il testo è stato inserito nel 1998 all’interno del volume Archivio Foucault III. Il titolo richiama con tutta evidenza il famoso articolo di Kant Risposta a una domanda: che cos’è l’illuminismo? pubblicato nel 1784. Esattamente due secoli dopo, Foucault torna su quell’articolo confrontandosi con le parole di Kant: non si limita a spiegarne il testo, ma lo reinterpreta e lo rilancia attualizzandone il contenuto. Anzi, fa qualcosa di più: eleva la Risposta di Kant al di sopra della sua storia, e dunque della sua inevitabile storicità, rendendola in qualche modo imperitura, almeno nelle intenzioni. L’operazione foucaultiana guarda infatti al presente e al futuro: tira fuori da quella storia – che è la nostra storia, la storia dell’Illuminismo e della sua battaglia di civiltà, la storia della ragione combattente e poi trionfante su ogni oscurantismo – un elemento sovrastorico, non riducibile all’età dei lumi, perché sempre replicabile in ogni contesto storico. Più che un elemento, un gesto. Foucault prende l’Illuminismo nella lettura che ne dà Kant e ne fa un gesto, mai compiuto una volta per tutte ma da compiere sempre di nuovo. È il gesto della critica. L’esercizio di un particolare habitus, quello che definiamo atteggiamento critico, che, come tale, non ha tempo, non è limitato a un contesto o a una particolare epoca storica, per quanto abbia sicuramente caratterizzato in modo particolare l’età moderna, la sua cultura, il suo Zeitgeist come si suol dire.
Quarant’anni dopo che ne è del gesto critico? Rileggere oggi Che cos’è l’Illuminismo? è l’occasione per riflettere sullo statuto attuale della critica. Foucault scrive infatti il suo saggio nel 1984, nel pieno di una fase storica e culturale in cui il pensiero critico sembra aver raggiunto il suo apice massimo: la seconda metà del Novecento vede non solo il trionfo ma l’intensificazione dell’atteggiamento critico in quasi tutti i campi del sapere, soprattutto del sapere umanistico, e in molti ambiti della vita consociata. Basti pensare all’approccio decostruzionista di Derrida o all’approccio genealogico dello stesso Foucault, che hanno contrassegnato un epoca, dentro e fuori l’ambito della riflessione filosofica. E a tutto ciò che ne é seguito: per fare qualche esempio, post-colonial studies, gender studies, disability studies,… Tutti ambiti di studi cui non si può negare una qualche filiazione, diretta o indiretta, coi nomi di Foucault e Derrida, tutti approcci volti a mettere in questione assunzioni dogmatiche inavvertite e presupposti a lungo dati per ovvii e pacifici che vengono ora a cadere uno dopo l’altro sotto la mannaia della critica. Il pensiero critico non ha risparmiato neppure i presupposti da cui muoveva lo stesso Illuminismo: alla fine del XX secolo l’uomo supposto universale di cui parla la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 si scopre essere nient’altro che il moderno uomo bianco occidentale maschio eterosessuale abile e cisgender. Sicché, giunto al suo apice filosofico, il gesto critico si fa talmente radicale da compiere un avvitamento virtuosistico su se stesso, torcendosi contro di sé, contro la propria stessa tradizione, contro la propria stessa istanza, intensificando alcuni esiti cui era già giunto il pensiero nietzschiano.
Non è un caso se il secolo successivo, quello in cui viviamo oggi, si apra con uno spirito inevitabilmente altro. Decostruito tutto, almeno sul piano della critica teorica, il pensiero occidentale ha iniziato a porsi il problema di come e cosa ricostruire. Ha ad esempio iniziato – o ripreso in modi nuovi – a chiedersi che cos’è un’istituzione, come funziona la legge, come si costruisce una comunità, guardando istituzioni, leggi e comunità non come trappole o gabbie della soggettività ma come possibili modi della sua espressione. Oppure ha iniziato – o ricominciato – a chiedersi cosa sia un sapere efficace che orienti la prassi e non si limiti a sospenderla ponendola in dubbio, guardando il sapere umanistico e scientifico non più (soltanto) come verità relativa, limitata, contingente e storicamente determinata, ma come operatività creativa in grado di generare nuovi concatenamenti, nuove aperture, nuove occasioni di vita. È come se negli ultimi vent’anni fosse cresciuto il desiderio di una pars construens che accompagni, integri o non sia del tutto assorbita dalla pars destruens.
Dunque, che ne è oggi del gesto critico? L’istanza che lo anima non é certo scomparsa, ma il suo senso e il suo ruolo risultano mutati rispetto a 40 anni fa.
Che cos’è l’Illuminismo?
Ripartiamo allora dal testo foucaultiano. E anzi, prima ancora, da quello kantiano. Qual era la risposta di Kant alla domanda: che cos’è l’Illuminismo?
Nel suo articolo, il filosofo di Königsberg risponde con la celebre e meravigliosa definizione che tutti conosciamo. L’Illuminismo è l’«uscita dallo stato di minorità». È cioè il momento storico in cui l’uomo decide di non essere più minorenne, di uscire dalla condizione «infantile» in cui aveva vissuto sino ad allora. Quale sarebbe questa condizione «infantile»? È la condizione in cui l’individuo non pensa con la propria testa, ma si affida all’autorità – sia essa incarnata dal funzionario governativo, dal sapere costituito, dal prete o dal medico. Per molto tempo l’umanità ha pensato ciò che l’autorità gli diceva di pensare, come un bambino che segue il dettato dei genitori. Con l’Illuminismo, invece, l’umanità abbandona questa condizione infantile (questo «stato di minorità») e si assume la responsabilità e il compito di pensare in modo autonomo. Così infatti Kant definisce l’«uscita dallo stato di minorità»: la «capacità di valersi del proprio intelletto senza la guida di un altro».
L’Illuminismo, allora, non si identifica con un insieme di valori, di idee e di progetti, ma con l’uso della ragione umana. Più precisamente, con un certo modo di usare la ragione umana (diremo a breve quale). Ma ciò significa: l’Illuminismo non è un contenuto, o un insieme di contenuti, che, come tali, potrebbero anche essere storicamente determinati, relativi a una certa epoca (il XVIII secolo), quindi del tutto contingenti e transeunti. L’Illuminismo è invece uno stile del pensiero, un atteggiamento, un gesto, come dicevamo. È un habitus, un «modo di fare», che, come tale, non è limitato a quella determinata epoca in cui noi generalmente collochiamo la cultura illuministica, non è relativo a quello specifico modo di pensare, non è soltanto tipico di quei particolari intellettuali settecenteschi che noi definiamo «illuministi», ma è un atteggiamento che è e resta valido per tutta l’umanità. Perciò è qualcosa di sempre attuale, ogni volta da riattualizzare. In questo senso l’uscita dallo stato di minorità non è un avvenimento accaduto nella storia, un fatto storicamente compiuto e già concluso, ma un compito sempre a venire. Per Foucault in questo compito ne va del nostro presente e del nostro futuro.
Ma guardiamo più a fondo il testo di Kant: come dobbiamo intendere esattamente lo «stato di minorità»? Qui cade la prima importante osservazione di Foucault.
Kant definisce lo stato di minorità come una condizione «che l’uomo deve imputare a se stesso». Se l’umanità resta in questa condizione infantile, non è perché l’autorità glielo impone o perché qualcuno la costringe. Se insomma l’uomo si comporta come un minorenne, è per sua stessa responsabilità: egli è minorenne non per un difetto di intelligenza, ma per mancanza di decisione e di coraggio (il coraggio di pensare con la propria testa). Osserva Foucault: lo stato di minorità – così come è inteso da Kant, se leggiamo bene il suo testo – è uno stato della nostra volontà, è una condizione in cui ci troviamo per pigrizia o per viltà. Perché è facile affidarsi a una guida, delegare ad altri, lasciare all’autorità o alla tradizione la responsabilità di pensare al posto nostro.
Per uscire dallo stato di minorità ci vuole allora uno scatto d’orgoglio, un atto di coraggio, un sussulto della volontà. L’uscita dallo stato di minorità, scrive Foucault, è un «cambiamento che l’uomo opera su se stesso». È un lavoro che l’uomo fa su di sé. Cade qui il riferimento a un tema che Foucault ha approfondito negli anni ’80 e a cui ha dedicato diversi testi: è il tema della cura di sé, che è anche il titolo del suo ultimo libro pubblicato in vita. Che cos’è la «cura di sé»? È un lavoro attraverso cui l’individuo plasma se stesso, è una trasformazione del proprio esser soggetti. La critica al potere, la resistenza a quella rete di sapere-potere che avvolge il soggetto e lo plasma nel suo modo di agire e di pensare, passa, per il filosofo francese, attraverso un lavoro su se stessi. Se siamo sempre immersi in relazioni di potere, l’antidoto sta anzitutto in un rivolgimento del nostro atteggiamento.
Per questo motivo, nota Foucault, l’Illuminismo ha un motto, una consegna che si impartisce a se stessi, un compito che si assegna alla propria individualità e, insieme, si propone agli altri. Di che si tratta? Il celebre motto con cui Kant identifica l’Illuminismo è «sapere aude!»: abbi il coraggio di sapere. Abbi l’audacia di usare il tuo proprio intelletto.
Osserva quindi Foucault: l’Illuminismo è un processo di cui gli uomini fanno parte collettivamente (ne sono tutti coinvolti) e un atto di coraggio da compiere personalmente (ognuno deve farlo da sé). Omnes et singulatim, per dirla con una formula cara al filosofo francese. Il quale, con queste osservazioni, sta toccando un problema: come dobbiamo intendere il rapporto tra individuo e collettività? Ad esempio, che rapporto deve intrattenere il soggetto con l’autorità (la legge, il governo, le istituzioni)? Come dobbiamo pensare il rapporto tra etica e politica, cioè tra la dimensione individuale e quella collettiva? Troviamo una soluzione se andiamo al cuore dell’articolo di Kant. E qui inizia la lettura molto originale che ne dà Foucault.
Ragione e ubbidienza
L’Illuminismo, abbiamo detto, è l’uscita dallo stato di minorità, che coincide con l’uso della ragione. Kant arriva a definire quale sia questo uso della ragione attraverso due significative distinzioni, che Foucault ritiene di grande rilevanza.
La prima è la distinzione tra la sfera dell’ubbidienza e la sfera dell’uso della ragione, tra il momento in cui bisogna ubbidire e quello in cui si deve ragionare con la propria testa. Come si regolano queste due sfere?
Nello stato di minorità, vige solo la prima, non la seconda. Per caratterizzare lo stato di minorità, infatti, il filosofo di Königsberg cita l’espressione: «ubbidite, non ragionate». È questa, a suo parere, la forma in cui si esercitano normalmente la disciplina militare, il potere politico, l’autorità religiosa.
Per caratterizzare la maggiore età troviamo invece una formula differente: l’umanità diventerà maggiorenne non quando smetterà di ubbidire, o non dovrà più ubbidire, ma quando le si dirà «ragionate quanto volete, ma ubbidite». Ad esempio: pagate le tasse ma ragionate quanto volete sulla fiscalità; garantite il servizio di una parrocchia, conformemente ai principi della Chiesa, ma ragionate quanto volete sui dogmi religiosi.
A questo punto Foucault lascia cadere un’osservazione decisiva: si potrebbe pensare che qui Kant stia indicando quella che noi oggi chiameremmo «libertà di coscienza». Ossia, il diritto di pensare come si vuole a condizione che si ubbidisca come si deve. E invece no. Perché qui il filosofo tedesco, con una mossa sorprendente che spariglia le carte, introduce un’altra distinzione.
La seconda distinzione che Kant delinea è tra l’uso privato della ragione e l’uso pubblico della ragione. Ma aggiunge subito: la ragione dev’essere libera nel suo uso pubblico, ubbidiente e sottomessa nel suo uso privato. E questo, nota Foucault, è esattamente il contrario di ciò che si intende con libertà di coscienza.
Per libertà di coscienza, infatti, noi solitamente intendiamo: ubbidire nel pubblico ed essere liberi di pensarla diversamente nel privato. Qui invece Kant sostiene che la ragione deve essere libera nel suo uso pubblico. Ma allora che cos’è questo uso pubblico della ragione? E che cos’è l’uso privato?
Entriamo così nel cuore della questione posta dall’articolo Risposta a una domanda: Che cos’è l’illuminismo?: cosa debba intendersi con Illuminismo in quanto stile di pensiero, in quanto atteggiamento, in quanto gesto, ossia come compito sempre attuale e ogni volta da riattualizzare. Nello stesso tempo, ci inoltriamo nel pensiero di Foucault, nel modo in cui egli rilegge il testo kantiano del 1784, donandogli nuova luce e, insieme, indicando un antidoto al potere e ai suoi processi di soggettivazione.
Uso privato e uso pubblico della ragione
Dunque, l’uscita dallo stato di minorità coincide con l’uso pubblico della ragione. Per comprendere di che si tratti, iniziamo dall’uso privato. Il primo aspetto da sottolineare, per chiarire cosa debba intendersi con «uso privato della ragione», riguarda la sua sfera di applicazione: tale utilizzo della ragione non è – come magari saremmo indotti a pensare – relativo alla sfera personale. Tutt’altro. Kant scrive che l’uomo fa un uso privato della ragione quando è «un pezzo di una macchina». Ovvero: quando ha un ruolo da svolgere nella società e delle funzioni da esercitare. Ad esempio: essere soldati, essere cittadini e avere le tasse da pagare, essere un funzionario governativo, essere un medico. Si badi: in tutti questi casi si fa un uso privato della ragione. Perché privato?
Foucault lo spiega così: parliamo di uso privato «quando l’uomo è un segmento particolare della società e si trova in una posizione definita in cui deve applicare delle regole e perseguire fini particolari». La chiave di volta sta in queste ultime parole: fini particolari. L’uso della ragione è privato quando è impiegato per fini particolari, non universali (in questo senso, fini «privati» e non «pubblici», anche se si tratta del lavoro di un funzionario pubblico). Quando, cioè, l’uomo che usa la ragione lo fa limitandosi a essere il «pezzo di una macchina» (per usare l’espressione di Kant), o un «ingranaggio» (direbbe Foucault), perseguendo i fini particolari propri di quell’ingranaggio. Potremmo dire: si fa un uso privato quando si utilizza la ragione affinché «la macchina funzioni», (ad esempio, la macchina della burocrazia statale, dell’esercito, dell’ospedale, ecc.).
Certo, la macchina deve funzionare. Kant non sta chiedendo che, quando si svolge il proprio ruolo di soldato o di medico o di funzionario, si pratichi un’obbedienza cieca e stupida, ma che si adatti la propria ragione a quelle determinate circostanze. In queste condizioni, la ragione deve quindi sottomettersi ai fini particolari richiesti per svolgere quel compito o quel ruolo che ha una rilevanza sociale.
L’uso privato della ragione è allora ciò che i filosofi della Scuola di Francoforte, come Adorno e Horkheimer, chiamano «ragione strumentale»: quella ragione piegata a realizzare un fine specifico, determinato, particolare, quell’uso del raziocinio che ha un’utilità immediata, circoscritta, relativa.
«Privato» significa, in ultima analisi, «relativo»: relativo a un fine già determinato e stabilito altrove. Per certi aspetti, è ciò che Hegel – riprendendo, tra l’altro, termini kantiani, ma riconfigurandone il senso – chiama «intelletto» (Verstand) contrapponendolo alla «ragione» (Vernunft): mentre quest’ultima ha di mira una comprensione globale, filosofica, più profonda, l’intelletto si applica limitatamente a problemi particolari, come quelli delle singole scienze empiriche. L’uso privato della ragione non è altro che la razionalità formale, calcolante, algoritmica, quella che dice: «per raggiungere il risultato x, devi compiere l’operazione y». Si tratta, in ultima analisi, della mera applicazione meccanica di una regola.
Diviene allora chiaro perché Kant parli, in questo contesto, di «obbedienza»: se io devo raggiungere quel determinato fine, devo applicare quella determinata regola. Non c’è altro. In un certo senso, è la ragione di cui fa uso l’ingegnere: se vuoi che un edificio stia in piedi, devi progettarlo e costruirlo attenendoti a determinati parametri. Ci si potrebbe chiedere: perché progettare quell’edificio, a quale scopo? Ma queste sono domande che esondano dai compiti dell’ingegneria, del tutto estranee ai suoi calcoli. Le ragioni politiche per cui l’amministrazione pubblica ha deciso quella costruzione non sono di competenza dell’ingegnere, il quale deve semplicemente attenersi a quanto stabilito altrove.
In conclusione, se volessimo dare una definizione chiara e semplice dell’uso privato della ragione, poteremmo chiamarlo efficienza tecnica. L’uso privato della ragione è meramente questo.
Ora possiamo facilmente intendere in che cosa consista, invece, l’uso pubblico della ragione: nel ragionare al di fuori di fini particolari e prestabiliti – semmai, nel ragionare proprio sui fini: perché quel fine? Chi lo ha deciso? In base a che cosa?
In questo caso si tratta di ragionare non in nome di una certa competenza disciplinare, di una certa limitata sfera di verità, di una certa limitata sfera di efficacia pratica, ma in nome dell’universale. E ragionare in nome dell’universale significa ragionare in nome di tutti gli uomini: non di un uomo particolare (in quanto ingegnere, in quanto medico, in quanto esperto specializzato in questa o quella disciplina, in questa o quella mansione). Ragionare in nome dell’umanità tutta: ecco, questo è l’uso pubblico della ragione che – sostiene Kant – dev’essere libero. Chiaro, allora, perché dev’essere libero: se fosse sottomesso a fini particolari («di parte»), a scopi circostanziati e relativi, non sarebbe davvero universale come dovrebbe.
L’Illuminismo come gesto
Veniamo così alle conclusioni cui giunge Foucault. La sua tesi è che comprendiamo davvero che cos’è l’Illuminismo, così come lo intendeva Kant, attraverso questa distinzione: uso privato e uso pubblico della ragione. L’Illuminismo è anzi questa stessa distinzione. È la capacità di tener ferma questa differenza e ripristinarla ogni volta di nuovo.
Vi sono invece oscurantismo, dogmatismo e tirannide ogni qualvolta questa distinzione scompare o è appannata. Quando, cioè, si ha una sovrapposizione tra l’uso pubblico e l’uso privato della ragione, quando questi due ambiti si confondono e l’uso privato viene presentato e smerciato come uso pubblico. Con questo non si vuole indicare soltanto quella commistione di interessi privati e interessi pubblici – dove i primi vengono spacciati per i secondi – che costituisce il cuore dei tanti mali della politica (nepotismo, familiarismo, corruzione, conflitto di interessi, abuso delle pubbliche funzioni). Si tratta di qualcosa di più profondo.
Vi sono oscurantismo, dogmatismo, tirannide quando l’uso privato si presenta come l’unico uso possibile della ragione. Quando, cioè, la ragione strumentale diventa l’unica ragione esistente, quando l’efficienza tecnica prende il sopravvento su qualsiasi altra istanza. Potremmo anche dire: quando ciò che dovrebbe essere un mero strumento, il mezzo, diviene un fine. Oppure: quando dei fini particolari e contingenti vengono spacciati per fini universali.
Se dovessimo esemplificare, potremmo prendere in considerazione il caso storico più eclatante, nonché inquietante, in cui la ragione strumentale ha preso il sopravvento: quella macchina efficientissima, razionalissima, che, nella Germania nazista, ha condotto allo sterminio di sei milioni di ebrei. Già, perché il progetto deciso da Hitler e realizzato dall’apparato poliziesco, amministrativo e burocratico dello stato tedesco di quegli anni costituisce, nel suo complesso, una macchina estremamente efficiente. Il genocidio degli ebrei, come noto, è stato pianificato in modo freddamente e lucidamente razionale, predisponendo tutti gli ingranaggi necessari per realizzarlo (dal gerarca nazista, che prendeva decisioni e dava ordini, sino al più umile impiegato dell’amministrazione statale, che si limitava a mettere il timbro sui fogli di trasferimento degli ebrei nei campi di concentramento). Ecco, qui vediamo l’uso privato della ragione (l’efficienza del dipendente dell’amministrazione statale nell’eseguire fini particolari stabiliti altrove) spacciato per uso pubblico, sino a cancellarne ogni traccia. Quell’uso pubblico della ragione che avrebbe dovuto far sorgere, anche nel più umile degli impiegati, qualche domanda sui fini che andava perseguendo. Sappiamo come si difesero i gerarchi nazisti, coinvolti nella Shoah e accusati di crimini di guerra, durante il processo di Norimberga: «Io ho semplicemente ubbidito agli ordini». Vale a dire: ho ubbidito alle procedure, alla ragione strumentale e ai suoi fini particolari. Come se quella fosse l’unica ragione esistente, l’unico modo possibile di usarla. Si nasconde qui la «banalità del male» descritta da Hannah Arendt in pagine celebri. In queste circostanze, l’uso privato della ragione ha completamente soppiantato l’uso pubblico, ossia quel modo di pensare che ragiona in nome dell’umanità intera e non semplicemente in nome di una singola parte (la Germania, la burocrazia nazista, la supposta «razza ariana» o la disciplina e il regolamento militari). In questo caso, una verità «di parte», l’idea di un’umanità «particolare», è stata spacciata come umanità universale, anzi come l’unica umanità degna di questo nome, tanto da voler cancellare coloro che non rientravano in quella categoria.
Quello dell’apparato nazista è certamente l’esempio più eclatante in cui la distinzione tra uso privato e uso pubblico della ragione è stata cancellata, in cui l’efficienza tecnico-procedurale si è presentata come l’unico uso possibile della ragione. Ma ognuno di noi può confondere o sovrapporre uso pubblico e uso privato della ragione nella misura in cui si limita a eseguire meccanicamente decisioni stabilite altrove. Anche l’insegnante può cadere in questa trappola, nella misura in cui si limita a ripetere in modo automatico il programma scolastico stabilito dal Ministero, svolgendolo magari alla perfezione («alla lettera», come si suol dire), scambiando però il mezzo con il fine (la «lettera» con lo «spirito»). Anche l’insegnamento, il sapere e la cultura possono cioè scadere a uso privato della ragione (spacciato o confuso per uso pubblico), laddove essi siano intesi come mero insieme di nozioni prestabilite da inculcare meccanicamente nella testa delle persone.
Lo stesso può accadere alla scienza, laddove questa sia guidata unicamente dal criterio dell’efficienza tecnica, trasformando lo scienziato in un impiegato che segue specifiche procedure metodiche. Ciò accade quando lo scienziato non s’interroga più sul senso (universale, non semplicemente particolare) del suo stesso operare, diventando un esperto, specializzato nel proprio piccolo campo, ignaro di tutto il resto. Senza, cioè, una visione globale e universale del mondo, che sappia farsi carico, ad esempio, delle conseguenze morali, etiche e politiche del proprio operato. È il problema che già denunciava Edmund Husserl nella Crisi delle scienze europee.
Si potrebbero fare molti altri esempi di perdita della distinzione tra uso pubblico e uso privato della ragione. Anche il parroco può cadere nella medesima fallacia, nella misura in cui si limita a eseguire i servizi parrocchiali, ripetendo meccanicamente quanto stabilito e scritto altrove (prendendolo «alla lettera» e, di nuovo, confondendo la «lettera» con lo «spirito», il mezzo con il fine). Lo stesso può dirsi del governo, persino di quello più democratico, nella misura in cui si limita a eseguire «ricette» stabilite altrove (magari da qualche esperto di economia e mercati finanziari) confondendo l’arte politica con la tecnocrazia.
È chiaro che non è sempre facile tracciare una netta divisione tra uso privato e uso pubblico. Quante volte è accaduto nella storia di scambiare il particolare con l’universale, ad esempio, un tipo particolare di uomo come paradigma dell’intera umanità? E quante volte accade ancora oggi di scambiare dogmaticamente una verità relativa per una verità assoluta (quel particolare modo di essere, quel particolare modo di agire, quel particolare modo di vivere, presi come se fossero la natura umana in quanto tale, negando dignità ad altri modi di essere, di agire e di vivere)? Secondo Foucault, questa divisione non è mai tracciata una volta per tutte, non sarà mai definitiva, ma è una linea che va ritracciata ogni volta.
Proprio perciò l’Illuminismo è un compito, un gesto ogni volta da riattualizzare. Si tratta, per così dire, di quel gesto che traccia la linea, che divide e separa. Un gesto che ognuno ha il compito di ripetere sempre daccapo. Così si salvaguarda la distinzione tra uso privato e uso pubblico, tra un modo di ragionare particolare, strumentale, relativo e un modo di ragionare universale, libero da fini specifici e contingenti.
In questo senso l’Illuminismo è un ethos che coinvolge tutti gli uomini collettivamente (è un’impresa da costruire insieme) e impegna ciascuno singolarmente (è un compito cui ognuno si deve dedicare in prima persona).
La critica oggi
Ora, che significato assume per noi il testo di Foucault 40 anni dopo?
In ultima analisi, quello di Foucault, come quello di Kant, è un elogio della critica. I loro due articoli sono tra i monumenti che la civiltà occidentale ha eretto alla capacità di giudizio critico. Se guardiamo la tendenza del pensiero filosofico degli ultimi vent’anni, di primo acchito sembra che l’aria sia cambiata. Due soli esempi tra i molti. Sia Bruno Latour nel suo Essere di questa terra sia Isabelle Stengers nel suo Tempo delle catastrofi guardano con sospetto l’intellettuale che dall’alto denuncia i mali del mondo, a partire da quelli climatici, e demolisce con la clava supposte verità esaurendo il proprio compito nell’esercizio della critica. Stengers scrive che «non si tratta di contestare l’utilità della critica né la sua necessità, quanto piuttosto la sua identificazione con un rimedio, vale a dire anche la sua trasformazione in un fine in sé». A risultare oggi incomprensibile, o molto meno comprensibile di un tempo, è l’esercizio critico fine a se stesso, come se fosse staccato dall’azione e dalla passione, come se fosse privo di godimento. C’è invece troppo spesso nella critica, laddove è concepita ed esercitata in termini puramente negativi, una forma di godimento alimentata da «passioni tristi» come paura, rabbia, risentimento. Ma in che consiste la critica laddove non è intesa come un rimedio e un fine in sé?
Saper giudicare, prendere le distanze, «distaccarsi da se stessi» secondo un motto foucaultiano, sono tutte espressioni che indicano un determinato tipo di atteggiamento, quello critico, ma, prima ancora, un determinato tipo di collocazione. Chi critica si colloca fuori, in alto, a distanza dal mondo. Ma «fuori» dove? C’è davvero un punto che può chiamarsi fuori dal mondo? Non per Foucault, il quale ha sempre sottolineato l’immanenza delle relazioni di sapere e di potere. Non c’è movimento verso l’alto, distanziamento verticale, nella prospettiva foucaultiana, solo un movimento orizzontale, sempre aderente alla vita. Ma allora esercitare la critica significa districarsi da determinate relazioni di sapere-potere intrecciandone di nuove. Sciogliere per riannodare diversamente. Restituire i legami alla loro potenza per istituirne altri dapprima impensabili. Letta in termini positivi, quindi, la critica è questo esercizio vitale di apertura e riarticolazione: un modo con cui la vita rievoca la propria potenza. Quella potenza virtuale che non si esaurisce mai nelle sue configurazioni attuali. Che cos’è, in questa prospettiva, la distinzione tra uso pubblico e uso privato della ragione, ovvero l’Illuminismo? Creazione di nuovi concatenamenti, apertura di mondi, intensificazione delle proprie capacità. Il gesto proprio dell’Illuminismo è il gesto della vita che si fa potenza.
Questo articolo è stato pubblicato su Le parole e le cose il 25 giugno 2024