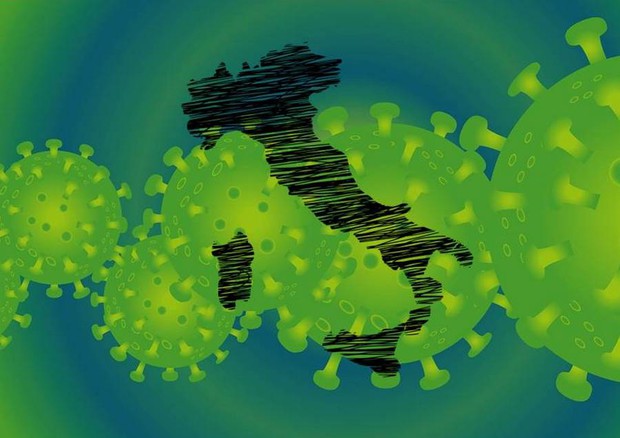Le regioni nate con l’ambizione di riformare lo Stato centrale e di promuovere una nuova classe dirigente, si sono trasformate in uno di principali ostacoli al miglioramento delle funzioni pubbliche
Nelle ultime elezioni regionali in Basilicata ha votato meno del 50% degli aventi diritto. In Abruzzo il 52,2% e in Sardegna il 52,4%. Partecipazione ancora più bassa si è registrata nel 2023 nelle regionali del Lazio (il 37,20%) mentre nello stesso anno si sono recati a votare solo il 41,6% degli elettori lombardi e il 48% dei molisani. I risultati peggiori di partecipazione al voto si sono avuti, dunque, nella regione più ricca d’Italia e in quella che comprende la sua capitale. Nel 2022 hanno votato per il nuovo presidente della regione il 49% dei siciliani. Nel 2021 in Calabria ha votato solo il 44,33% degli aventi diritto. Risultati migliori si sono registrati nelle regionali del 2020: dal 53,45% in Liguria al 67, 67% in Emilia-Romagna (anche se 5 anni prima si raggiunse appena il 37,71%, la percentuale più bassa mai registrata in una elezione in quella regione), dal 55, 53% della Campania al 66% del Friuli- Venezia Giulia. Nel 1970, invece, alla nascita delle regioni partecipò più del 90% dei votanti. Dopo 30 anni (nel 2000) la partecipazione scende già di 20 punti; 50 anni dopo si oscilla tra un terzo a meno della metà, mentre la stragrande parte si colloca poco oltre il 50% di votanti, con qualche eccezione. L’istituzione regionale che dovrebbe essere quella più vicina ai cittadini, al punto da volerla trasformare nell’istituzione cardine della nazione, si mostra la più lontana o la meno amata. Anche se all’interno di una costante caduta della partecipazione elettorale, si vota di più nelle elezioni politiche o in quelle comunali. La domanda viene naturale: come mai si vuole riorganizzare lo Stato e sfasciare la nazione a favore di una istituzione che è sentita meno importante del proprio municipio o del governo nazionale?
È questo uno dei misteri della politica italiana degli ultimi anni. Le regioni nate con l’ambizione di riformare lo Stato centrale e di promuovere una nuova classe dirigente, si sono trasformate in uno di principali ostacoli al miglioramento delle funzioni pubbliche e stanno riproponendo una rifeudalizzazione della politica, ancora più accentuata nel Sud. In ogni caso non si sono dimostrate affatto più efficienti e più vicine ai cittadini di quello che ci si aspettava. E mentre un tempo i politici regionali non vedevano l’ora di passare ad altri livelli, oggi è difficilissimo smuovere un presidente di una regione dal suo ruolo, anzi molti di essi vorrebbero restarci a vita. D’altra parte, se il sistema sanitario nazionale è in profonda crisi e se le regioni hanno competenza piene in materia, come si può immaginare di concedere loro ancora maggiori funzioni quando sulla sanità (che impegna più di due terzi dei loro bilanci) sono state agenti attivi dello sfascio, pur con qualche notevole eccezione? Nessuna grande emergenza sanitaria, come la pandemia da Covid ci ha dimostrato, può essere affrontata con queste frammentate competenze regionali. Insomma, sarebbe il caso che nel sistema politico italiano, a destra e a sinistra, si riflettesse sul fatto che le regioni rappresentano l’esempio più clamoroso di eterogenesi dei fini di una istituzione elettiva in Italia.
Gli anni che precedettero e seguirono la nascita delle regioni in Italia furono caratterizzati da grandi aspettative, a volte quasi palingenetiche. In quel periodo storico si intravedevano i limiti profondi dell’organizzazione dello Stato, logorato dal clientelismo nelle scelte degli apparati e dal loro scarso senso delle funzioni pubbliche, e cominciava a delinearsi la questione morale, poi sollevata efficacemente da Enrico Berlinguer come conseguenza dell’occupazione dello Stato da parte dei partiti politici. Si intravedevano anche i limiti dell’intervento “straordinario” nell’economia meridionale. Per cui l’istituzione delle regioni si caricò di tre esigenze: riformare lo Stato centrale e renderlo più efficiente in periferia, promuovere una classe dirigente più adeguata e meno esposta alla corruzione, accelerare lo sviluppo del Sud e ridurre i dislivelli in economia e nei servizi. Obiettivi che sono stati clamorosamente mancati. Segnalo al riguardo alcune riflessioni di pochi anni fa di Sabino Cassese: “Le regioni si sono comportate come parti di una confederazione rissosa, non come componenti di un organismo unitario, quello che la Costituzione chiama Repubblica, una e indivisibile. I loro presidenti hanno agito come tanti shogun in concorrenza con l’imperatore”. Per quanto riguarda il superamento del divario tra Nord e Sud, esso si è accentuato ancora di più proprio a partire dalla nascita delle Regioni, sommando alla disuguaglianza nelle opportunità di lavoro quella nel funzionamento di servizi. Le regioni meridionali, in particolare, sono componenti attive dell’arretratezza dei loro territori. Negli ultimi anni la Lega di Bossi e Salvini ha apportato altri argomenti all’elogio di un federalismo sempre più vicino a un concreto secessionismo. In particolare, la teoria in base alla quale la globalizzazione avrebbe accentuato la competizione tra regioni e non tra nazioni si è afflosciata di fronte all’evidenza che proprio oggi reggono meglio nel mondo le economie ben strutturate in forti nazioni. L’Italia è diventata una dei paesi più sviluppati quando si è presentato unito nella competizione internazionale ed è entrato in crisi quando si è maggiormente disunito. Le regioni sono state un acceleratore di disunità e, quindi, di crisi. Vale per la vita dei singoli e per le nazioni il motto di Paolo Sorrentino: non ti disunire. D’altra parte, provare a far passare alla Camera l’Autonomia differenziata appena dopo il 25 Aprile dimostra come sia difficilissimo per la destra italiana dichiararsi antifascista e dimostrarsi unitarista.