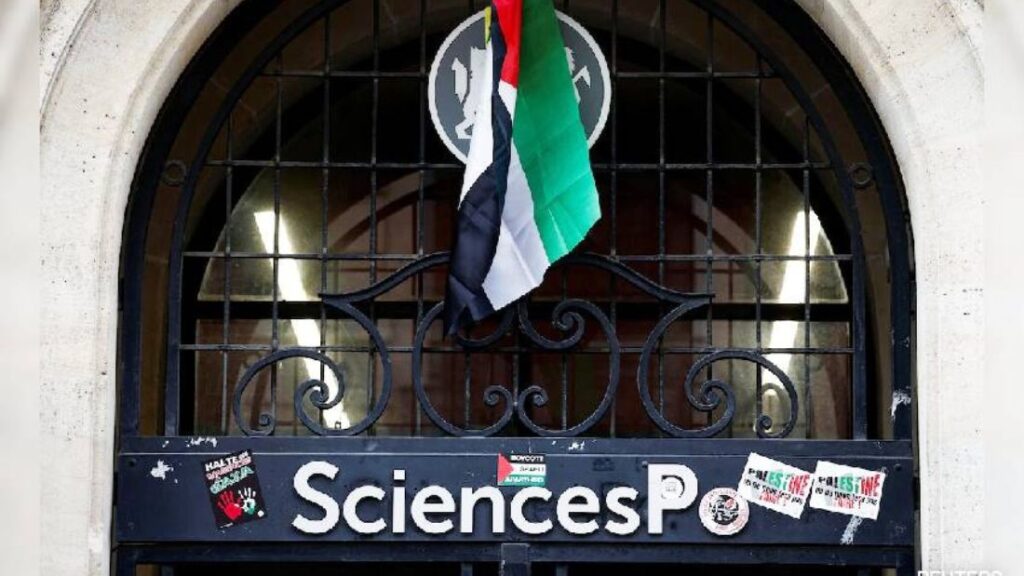Le immagini, come le parole, sono segni, tracce visibili che consentono la lettura del reale. I segni che oggi ci parlano sono righe di sangue sui volti dei ragazzi, macchie incrostate tra i capelli, lividi e ferite su braccia levate a proteggere la testa, ma soprattutto sguardi sgomenti e increduli, prima ancora che impauriti, che ci interpellano e ci chiedono conto.
A Pisa e Firenze il 23 febbraio, a Napoli, Torino e Bologna il 13 febbraio, a Torino il 27 ottobre e il 5 dicembre dello scorso anno, ragazzi e ragazze esposti a cariche di polizia in tenuta antisommossa mentre manifestavano in modo pacifico, senza bastoni né caschi. Spesso minorenni, spintonati a terra, perquisiti, i corpi schiacciati contro l’asfalto.
Soglia dopo soglia, il Paese pareva abituarsi a un clima di intimidazione, all’accettazione passiva di una retorica di ordine e disciplina, a una repressione del dissenso più consona a regimi e ordinamenti politici dai quali le democrazie hanno il dovere di distinguersi.
Ma ecco due fatti a rassicurarci: la manifestazione imponente, spontanea, ignorata dalle televisioni ma rimbalzata sui social nella notte del 23 febbraio a Pisa, dove migliaia di persone si sono raccolte in due piazze distinte per manifestare solidarietà agli studenti, e la nota del Quirinale dopo la telefonata del Presidente della Repubblica al ministro dell’Interno, che andrebbe stampata e affissa su scuole e caserme: «L’autorevolezza delle Forze dell’ordine non si misura sui manganelli ma sulla capacità di assicurare sicurezza tutelando, al contempo, la libertà di manifestare pubblicamente opinioni. Con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento».
Le manifestazioni degli studenti sono un affacciarsi alla vita civica, esprimono il desiderio di agire la cittadinanza, assumere l’esercizio democratico e costituzionale della partecipazione e del dissenso, e vanno interrogate e accolte, non represse. Ma che scuola stiamo preparando per i nuovi cittadini? Una scuola dell’ordine che potrebbe presto introdurre una norma «per far sì che chi occupa, se non dimostra di non essere coinvolto nei fatti, risponda civilmente dei danni che sono stati cagionati», come ha affermato il ministro dell’Istruzione e del Merito in un’intervista a “La Stampa” (13 febbraio). «Solo dimostrando di essere del tutto estranei, uno può vincere», ha detto il ministro.
Nel frattempo una legge in discussione in Parlamento prevede forti aggravanti di pena per l’aggressione a scuola di docenti, presidi o personale, con un procedimento penale avviato non solo su denuncia della vittima, ma anche da parte delle istituzioni, intese come soggetto di un «danno d’immagine o reputazionale dello Stato». E si invita alla bocciatura di chi occupa causando danni: «Credo che studenti di questo tipo non possano essere promossi all’anno successivo». Solo nel 1998 è stato abrogato un regio decreto del 1925, in piena epoca fascista, che sanciva provvedimenti disciplinari per gli studenti che andavano dall’ammonizione alla sospensione da 5 fino 15 giorni, per giungere alla bocciatura e all’espulsione da tutti gli istituti del Regno d’Italia.
È giunto il momento che ci si fermi a riflettere su un’ipertrofia punitiva e repressiva nel Paese che si sostanzia in compressione del dissenso e atti intimidatori, come l’identificazione da parte della Digos di chi alla prima della Scala ha gridato un concetto che è sottotesto della nostra Costituzione, «Viva l’Italia antifascista», o di chi, a Milano, ha deposto fiori in segno di cordoglio per l’uccisione del dissidente russo Aleksej Navalny.
Nell’ultimo anno, abbiamo assistito a una impressionante proliferazioni di reati e fattispecie di reato, in media 15 al mese; a un ddl Sicurezza che prevede carcere fino a sei anni per chi attua forme di protesta passiva; a una sorta di querulomania del potere, che ha portato molti esponenti politici a dichiararsi diffamati e minacciare o intentare causa, con evidente risultato di intimidazione su giornalisti critici e oppositori, sino ad arrivare alla proposta di un Daspo per gli artisti che esprimano opinioni difformi.
Nel restringimento progressivo della possibilità di dire, accade allora che si manifestino delle invenzioni simboliche, come è successo a Sanremo, dove Ghali ha portato in scena il pupazzo di un alieno per parlare di Palestina, e Dargen D’Amico si è presentato con una collana di pelouches per parlare di naufragi di migranti, gli stessi pelouche portati sulla spiaggia di Cutro per esprimere cordoglio per i bambini annegati.
Il ricorso a un’invenzione simbolica necessaria a dire qualcosa che altrimenti non è consentito usando segni infantili, in dichiarata assenza di qualsiasi volontà aggressiva, è una spia di un clima che sta diventando troppo stretto.
La criminalizzazione del conflitto si sta declinando anche nel linguaggio che utilizziamo. Tutti noi finiamo per introiettare un’idea di autocensura, in una sorta di algospeak – il modo di parlare sui social condizionato dagli algoritmi di intelligenza artificiale che bloccano, ritenendole offensive, parole dialettali o d’uso comune, che dunque devono essere mascherate, “se$$o”, o “P@@lestina”. Succede su Facebook, Instagram, YouTube e TikTok, su argomenti politici e di politica internazionale, e sarebbe stato una fonte di ispirazione per Orwell.
Ci siamo abituati nel contempo a un linguaggio che enfatizza parole come patria, nazione, orgoglio, fedeltà, depotenziando il paradosso degli abbracci con un presidente argentino che ha appena dichiarato che lo Stato è criminale, o di un vicepresidente del Consiglio assolto per aver detto che «la magistratura è un cancro da estirpare» in ragione della tenuità del fatto.
Le parole del Presidente Mattarella ci sollevano e ci danno un appiglio, le vediamo come un argine da frapporre a segnali come il disegno di legge presentato pochi giorni fa per la creazione di un corpo di diecimila riservisti pronti a combattere e utilizzabili per «il presidio del territorio insieme a polizia e carabinieri in caso di emergenze nazionali».
Sarebbe invece opportuno adottare finalmente i codici identificativi per tutte le forze di Polizia adibite a compiti di ordine pubblico, anche a loro tutela, ad uso esclusivo della magistratura, come nella maggior parte dei Paesi europei.
Questo articolo è stato pubblicato su La Stampa il 25 febbraio 2024