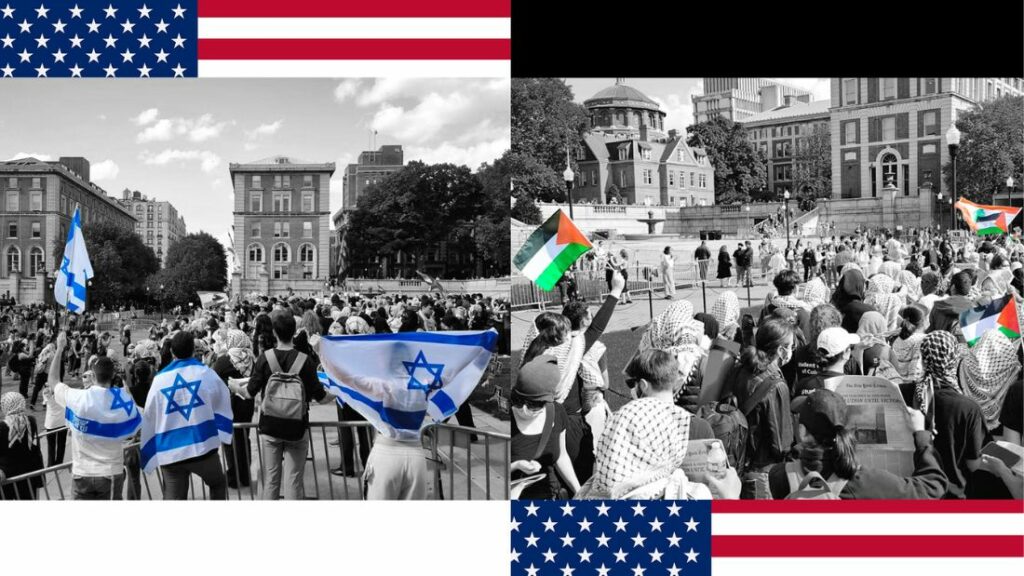Non è facile guardare in viso un uomo che ha conservato un sorriso dolce, timido, dopo trentatrè anni di carcere per un reato mai commesso. Era un pastore, Beniamino Zuncheddu, non aveva ancora compiuto ventisette anni quando le porte della casa circondariale di Badu ‘e Carros si sono chiuse dietro di lui con la terribile eco delle parole “fine pena mai”. Per più della metà della sua vita ha vissuto spostato di cella in cella, in differenti carceri sardi, senza poter usufruire degli istituti premiali previsti dalla legge, avendo sempre rifiutato di dichiararsi colpevole di un reato al quale era estraneo. “Desideravo avere una famiglia, costruire qualcosa, essere un libero cittadino come tutti. Trent’anni fa ero giovane, oggi sono vecchio. Mi hanno rubato tutto”.
In libertà da due mesi grazie a un’ordinanza di scarcerazione emessa dalla Corte d’appello penale di Roma, il 26 gennaio è stato assolto per non aver commesso il fatto: per non essere stato lui a spezzare la vita di tre pastori e a lasciarne un altro gravemente ferito, l’8 gennaio 1991, in quella che venne chiamata la strage del Sinnai.
Non ci assolve, parlare ora della liberazione di Beniamino Zuncheddu. La sua vita è stata dimenticata anche da noi. Liquidato dalle cronache giudiziarie, abbandonato all’arbitrarietà della ricostruzione dei fatti e alla soggettività delle sentenze, il suo caso è diventato un errore che si riperpetua, come accade in genetica nella cieca riscrittura di codice delle sequenze del Dna, lasciando a poche persone – alla sua comunità di origine, a un giovane e ostinato avvocato, ad alcune provvidenziali espressioni della società civile – il compito di porre rimedio là dove le istituzioni hanno scavato un baratro.
L’accusatore di Zuncheddu, unico superstite della strage che per decenni lo aveva inchiodato al crimine, non è stato considerato credibile. “Ho sbagliato a dare ascolto alla persona sbagliata”, ha detto in una drammatica testimonianza, riandando con la memoria a quando l’agente di polizia incaricato delle indagini gli mostrò una foto di Zuncheddu indicandolo come il colpevole della strage.
Un errore giudiziario, il più lungo della storia della Repubblica, costellato di ritrattazioni, depistaggi, false testimonianze, ostinazione a mantenere un impianto accusatorio segnato dal pregiudizio. “Non provo rabbia”, ha detto Zuncheddu con sintesi esemplare di mitezza e severità, “perché sono vittime anche le persone che mi hanno accusato. Non è colpa loro, ma del poliziotto, che fa parte della giustizia”.
Che fa parte della giustizia: un concetto espresso con tale nitore da impedirci di distoglierne lo sguardo. Potrebbe essere così per tutti, appesi a un filo che separa l’innocenza dalla colpevolezza. Appesi a un possibile arbitrio. È per questo che tanta importanza ha la giustizia, e chi “fa parte della giustizia”, nella nostra vita civile: la sua amministrazione, la sua indipendenza, i suoi organi di controllo, la garanzia dei tre gradi di giudizio dove la decisione non è presa solo una volta, dove ogni storia, ogni inciampo o precipizio che si condensa in un crimine può essere interrogato da diverse angolazioni, ogni prova può essere sottoposta a vaglio, e ogni verità riconsiderata e sottoposta a verifica.
Abbiamo visto, negli anni, progetti di delegittimazione della magistratura che avrebbero come esito quello di lasciare lo spazio della giustizia al più forte, al più ricco, al più influente, fino alla garanzia dell’impunità, quando la giustizia, per essere tale, deve essere soprattutto quella del più povero, del più marginale, del più abbandonato. Accade invece che proprio le vite più fragili possano diventare vittima di indifferenza, stereotipi, pregiudizio che si fa giudizio. Pierre Boulle, nel romanzo La faccia o Il procuratore di Bergerane, del 1953, ricostruisce tutte le fasi che portano all’edificazione dell’errore giudiziario, dove l’integerrimo procuratore vuole consegnare un colpevole agli abitanti della cittadina, dando forma a un impianto accusatorio che finisce con l’autoalimentarsi.
La macchina giudiziaria può allora trasformarsi in una disumana fabbrica di errori, per cortocircuiti di ordine psicologico, politico e sociale, per il ruolo dell’opinione pubblica e della stampa, per proteggere lo Stato e i suoi informatori, ma anche per mancanza di tempo, per cecità delle procedure in assenza di confronto con la realtà, quando chi deve decidere è oberato, sommerso dalle carte, privato del tempo necessario all’incontro con la realtà.
Eppure sarebbe bastato prenderci un caffè, ha detto il suo avvocato.
“Sì, mi hanno liberato, ma oggi sono poco più di un cadavere”, sono le parole di Beniamino Zunchedda. Da lui, dal suo sguardo, dalle sue miti parole può venire un profondo ripensamento.
In Il bene sia con voi, note di un viaggio in Armenia alla ricerca di risposte sui genocidi del Novecento, sulla sopraffazione e sulla “bontà illogica” dell’uomo, il grande scrittore ebreo ucraino di lingua russa Vassilij Grossman prese i pastori armeni e le loro greggi come figurazioni di tutte le vittime di secoli di abbandono e pregiudizio. “Le pecore hanno gli occhi chiari – acini d’uva e di vetro. Le pecore hanno un profilo umano – ebreo armeno, misterioso, indifferente, muto. Sono millenni che i pastori guardano le pecore. Le pecore guardano i pastori, e ormai hanno preso a somigliarsi. È come se gli occhi delle pecore guardassero gli uomini in un modo particolare”.
Questo articolo è stato pubblicato su La Stampa il 28 gennaio 2024