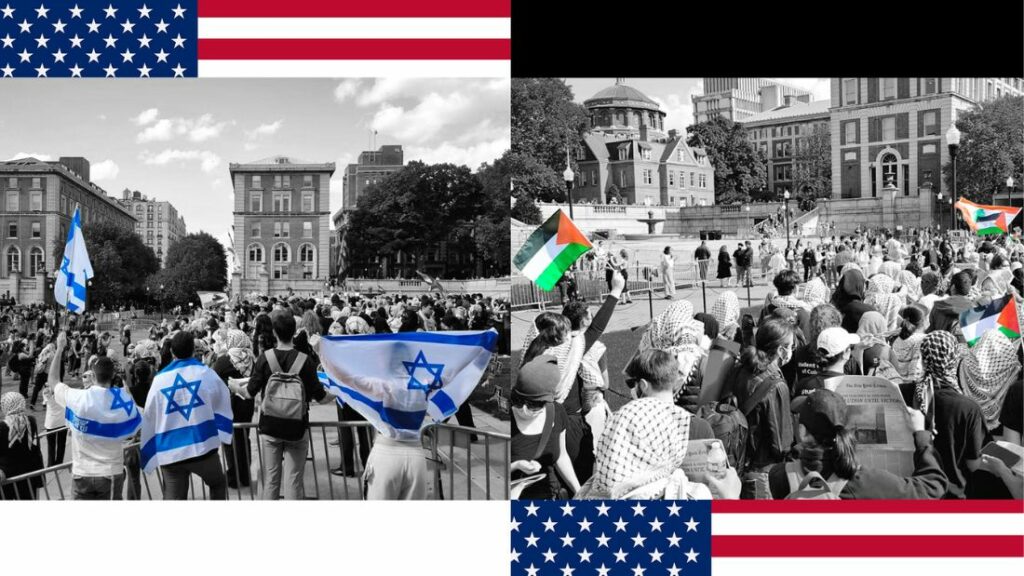Nei momenti in cui più grave è la crisi e più alti l’emotività e il dolore, è necessario ritornare a uno degli insegnamenti più lucidi di Edgar Morin, scritto su twitter in riferimento alla guerra in Ucraina: “E’ una debolezza intellettuale estremamente diffusa pensare che la spiegazione sia una giustificazione”. Insieme alla condanna di tutte le violenze ed alla solidarietà con tutte le vittime, è quindi più che mai opportuno iniziare un ragionamento su questa nuova fase della guerra israelo-palestinese riconoscendo che storicamente “c’è un oppresso e c’è un oppressore”: l’oppresso è il popolo palestinese, i cui territori sono occupati illegalmente fin dal lontano 1967; l’oppressore è il governo israeliano, oggi in mano all’estrema destra, che nel solo 2023, prima dell’attacco di Hamas del 7 ottobre, ha ucciso attraverso raid militari e bombardamenti a Gaza, in Cisgiordania e su Jenin, 200 palestinesi, compresi civili e bambini, senza contare le vittime dei coloni israeliani. Una situazione che più volte Amnesty International ha definito “crudele sistema di apartheid contro i palestinesi”. Dunque l’azione di guerra dell’ala militare di Hamas – organizzazione fondamentalista islamica che governa la disperata striscia di Gaza – che ha preso di mira terroristicamente anche i civili, esito anche di decenni di odio accumulato contro gli oppressori, si può configurare come contro-violenza, tecnicamente “controffensiva” in una guerra asimmetrica in cui, più che in altre, il terrorismo – cioè il colpire deliberatamente e spietatamente i civili – è da sempre parte integrante delle operazioni belliche da entrambe le parti.
Una catena della violenza, al cui interno è pura follia da parte di Hamas pensare di sconfiggere militarmente l’occupazione di Israele – lo stato più militarista e militarizzato del mondo – con la guerra e la violenza efferata sui civili. Chi ne pagherà, ancora una volta e sempre più massicciamente, le conseguenze di questo sciagurato attacco – anzi le sta già pagando, mentre scriviamo, con centinaia di morti e migliaia di feriti, causati dalla risposta militare israeliana, che si annuncia “senza precedenti” – è proprio il martoriato popolo palestinese. Oltre all’opposizione, anche pacifista, in Israele, ridotta al silenzio: “le manifestazioni previste per stasera” – dice l’attivista israeliana Meir Margalit, oppositrice del governo di Benjamin Netanyahu, raggiunta da il manifesto (8, ottobre, 2023) – “sono state cancellate e molti organizzatori hanno dato supporto alle forze israeliane”.
Anche in Palestina, allora, la via maestra per la liberazione è la lotta nonviolenta, che proprio in quei territori ha già dato esempi storici di grande importanza, dei quali è meglio non perdere la memoria. Li ricorda, tra gli altri, Erica Chenoweth nel suo Come risolvere i conflitti. Senza armi e senza odio con la resistenza civile (Sonda, 2023) a partire dalla Prima intifada (rivolta)nel 1987 quando, di fronte all’ennesima violenza gratuita dell’esercito israeliano contro civili inermi, vi fu l’avvio di una lotta popolare, con una grande partecipazione delle donne palestinesi, il cui “Comando assunse l’impegno formale di evitare l’uso della violenza armata e si diede il compito di persuadere il maggior numero possibile di comunità locali palestinesi a portare avanti un’azione nonviolenta anche di fronte all’uso di una forza letale da parte dell’esercito israeliano”. Si trattava di interrompere la catena della violenza.
La scelta della nonviolenza fu fatta consapevolmente per suscitare empatia nei confronti della propria lotta da parte della comunità internazionale, oltre che dell’opinione pubblica israeliana. Vi presero parte centinaia di migliaia di palestinesi, in tutti i territori occupati, con scioperi, proteste, manifestazioni, azioni dirette (al 98% nonviolente, secondo gli organi di sicurezza israeliani), anche se i media enfatizzavano il lancio delle pietre da parte dei ragazzi contro i carri armati, che portarono da un lato ad una repressione durissima dell’esercito israeliano, ma dall’altro lato in Israele prese il via il fenomeno dei refusenik, i giovani obiettori di coscienza che rifiutano il servizio militare, ed ebbero una grande spinta i movimenti pacifisti come Peace now e Donne in nero: i diritti dei palestinesi erano finalmente riconosciuti da una larga parte di opinione pubblica israeliana e mondiale. E nessuno potè aggettivare quella lotta come “terrorista”. Questi eventi portarono ai colloqui di pace di Oslo e di Madrid, culminati nello storico accordo del 1994 che garantiva l’autonomia palestinese nel governo della Cisgiordania e nella striscia di Gaza, portando ad un parziale ritiro delle truppe israeliane da entrambe le regioni. Contemporaneamente l’OLP, Organizzazione per la Liberazione della Palestina, riconobbe il diritto all’esistenza dello Stato di Israele. Una soluzione parziale e interlocutoria, certo, ma che ha mostrato la via giusta per raggiungere la coesistenza pacifica dei due popoli.
Ossia la via maestra della nonviolenza, come indicato anche da Olga Karach, attivista pacifista bieolorussa perseguitata dal suo governo per il sostegno attivo agli obiettori di coscienza, che ha parlato in rappresentanza anche dei movimenti pacifisti russi ed ucraini dal palco de La Via Maestra – la grande manifestazione di Roma per la Costituzione – lo stesso 7 ottobre, poche ore dopo l’avvio dell’offensiva di Hamas, chiedendo il cessate il fuoco nella guerra russo-ucraina e il sostegno agli obiettori di coscienza di tutte la parti in conflitto, come mezzo di azione nonviolenta. La via della violenza, anche degli oppressi, invece, va nella direzione opposta. In Palestina come in Ucraina.
Questo articolo è stato pubblicato su Il Fatto Quotidiano e Annotazioni il 9 ottobre 2023