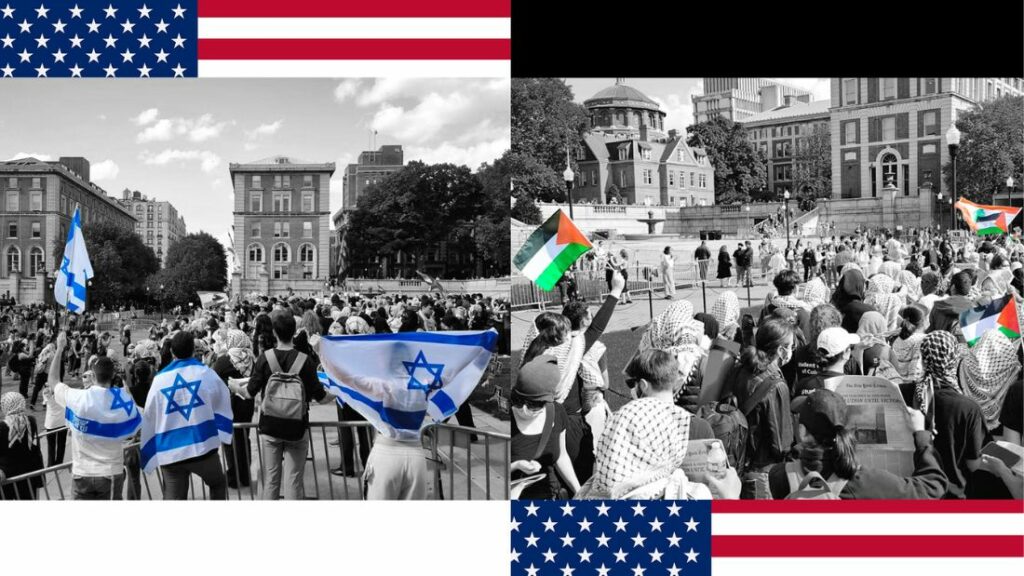La tornata elettorale per la presidenza della Repubblica appena conclusa è stata l’occasione per osservare come il sistema giuridico statunitense offra – nascoste nelle pieghe interne del suo DNA costituzionale- a chi le voglia cogliere, ulteriori possibilità di scivolamenti autoritari
Nessuno mai in tempi recenti aveva messo a dura prova le basi giuridiche disegnate dai padri fondatori nel 1787 a Philadelphia per i nascenti Stati Uniti, come ha saputo fare Donald Trump nei suoi quattro anni di presidenza. Nessuno come lui è riuscito a mostrare tutta la fragilità di una democrazia, che troppe volte ha rischiato di collassare a causa della capacità dell’uomo di cogliere e sfruttare a proprio vantaggio i tanti aspetti contraddittori nascosti nelle pieghe del sistema costituzionale statunitense. Certo il coup de théatre dell’assalto a Capitol Hill chiude con una violenza illegittima il periodo del suo mandato. Se, tuttavia, nel 2016 Donald Trump ha potuto diventare Presidente degli Stati Uniti d’America nonostante avesse ottenuto quasi tre milioni di voti in meno rispetto alla sua avversaria, assicurarsi poco dopo -con la nomina a giudice di Neil Gorsuch- il sostegno della Corte Suprema alle sue politiche migratorie discriminatorie, mettere pesantemente a rischio a suo vantaggio il funzionamento dei checks and balances fra poteri dello Stato, evitare la condanna dopo l’impeachment aggirando il diritto della House of Representatives di ottenere i documenti comprovanti la sua colpevolezza, e se –soprattutto- ha potuto giocare la sua ultima partita elettorale mantenendo nell’incertezza del risultato i suoi fans e il mondo intero per più di due mesi -fino allo showdown finale del 6 gennaio- è anche perché ha saputo approfittare degli assists che i risvolti opachi del diritto statunitense gli hanno offerto.
E’ stato il meccanismo del collegio elettorale, previsto dalla Costituzione per la nomina del presidente della repubblica, a permettergli – come già si è cercato di spiegare nelle pagine di questa rivista: https://www.questionegiustizia.it/articolo/amy-coney-barrett-nel-dilemma-democratico – di assumere l’incarico con il voto della minoranza degli americani. Sono d’altronde le stesse regole costituzionali che presiedono alla nomina dei giudici della Corte Suprema a sospingerli verso un’interpretazione delle norme in sintonia con chi li ha scelti politicamente. Un giudiziario troppo allineato a un esecutivo eccedente ha così consentito a Trump pericolosissimi straripamenti incostituzionali (si pensi alla questione del muro e all’appropriazione da parte dell’esecutivo della prerogativa della “borsa” costituzionalmente appartenente al Congresso, su cui: http://temi.repubblica.it/micromega-online/trump-il-muro-con-il-messico-e-l%E2%80%99inquietante-decisione-della-corte-suprema/). Regole, infine, che attribuiscono al Senato nel processo di impeachment la possibilità di decidere di non ammettere gli elementi di prova a carico del Presidente, hanno dato copertura alla sua ostruzione alle indagini e nascosto al mondo intero le eventuali prove dei suoi misfatti (cfr.: https://www.questionegiustizia.it/articolo/trump-e-la-sfida-al-diritto-impeach-or-perish_15-01-2020.php).
La tornata elettorale per la presidenza della Repubblica appena conclusa è stata l’occasione per osservare come il sistema giuridico statunitense offra – nascoste nelle pieghe interne del suo DNA costituzionale- a chi le voglia cogliere, ulteriori possibilità di scivolamenti autoritari.
Se infatti Donald Trump ha potuto tenere in bilico per tanto tempo la definitività del risultato elettorale non è solo perché è richiesta la sua concession, che a lungo non è arrivata, ma è anche perché il Presidente, sconfitto dal voto popolare, ha cercato di sfruttare a proprio vantaggio l’ambiguità del dettato costituzionale in relazione alla nomina dei grandi elettori, che la sezione 1 dell’articolo II affida ai parlamenti statali di effettuare nel modo che ritiene più opportuno. Nei risvolti di quel dettato egli ha scorto, infatti, la possibilità di ottenere un capovolgimento a suo favore del risultato elettorale, sol che fosse riuscito a convincere i parlamenti degli Stati a maggioranza repubblicana, in cui ha perso con uno scarto ridotto, a nominare una lista di grandi elettori sostitutiva o aggiuntiva rispetto a quella scelta dal popolo. Le telefonate allo Speaker della camera della Pennsylvania Bryan Cutler, gli inviti alla Casa Bianca dei delegati parlamentari degli Stati in bilico, l’appello al governatore della Georgia, Brian Kemp, affinchè convocasse il parlamento in seduta straordinaria prima della votazione dei grandi elettori il 14 dicembre (https://www.nytimes.com/2020/12/08/us/politics/trump-pennsylvania-house-speaker.html), avevano infatti come scopo proprio quello di giocare la carta di un intervento parlamentare successivo al suffragio popolare, che si sostituisse alle corti nel dichiarare quelle presunte irregolarità di voto che il giudiziario in più di 50 cause non aveva riconosciuto. Un’alternativa apparentemente percorribile in base alle norme (cfr.: https://www.questionegiustizia.it/articolo/trump-v-biden-il-paradosso-costituzionale-di-una-poltrona-per-tre), stoppata però sul nascere dalla fredda accoglienza dei parlamentari repubblicani, su cui pur il Presidente contava di far felicemente pressione politica, forte della sua imponente base elettorale.
Per quanto invece certamente non utile nel caso di specie a Trump, che non poteva contare sull’espressione a suo favore della camera bassa a maggioranza democratica, una seconda via di rovesciamento del voto popolare è inoltre racchiusa nelle pieghe del diritto statunitense, che permette al nuovo Congresso, insediatosi il 3 gennaio, di escludere i suffragi dei grandi elettori degli Stati quando ritiene siano stati irregolarmente nominati. L’Electoral Count Act del 1877, poi codificato nel titolo 3 dello U.S. Code, al capitolo 1, § 15, stabilisce infatti che qualora vi sia una obiezione scritta proveniente dal rappresentante di una camera, che sia appoggiata da almeno un rappresentante dell’altra, in relazione ai voti provenienti dai singoli Stati -così come letti uno dopo l’altro in ordine alfabetico stato per stato-, Camera e Senato si dovranno appartare per decidere su di essa e, qualora vi sia l’accordo fra i due rami del parlamento, i voti posti in discussione potranno essere invalidati.
Anche qui si tratta di un controllo parlamentare – questa volta a livello federale- che si sostituisce al giudiziario nella decisione relativa alla regolarità dei voti per l’elezione del Presidente e che presenta l’inquietante aspetto di aver l’astratta capacità di sovvertire il voto popolare, sol che al Congresso si sia formata una maggioranza ostile rispetto a quella espressa attraverso il voto per i grandi elettori. E’ stata proprio quella astratta possibilità, sia pur in concreto non praticabile, ad aver permesso a Trump di mantenere alta la tensione fra i suoi sostenitori, fino a provocare il loro assalto a Capitol Hill il giorno in cui le obiezioni, che hanno trovato il supporto di ben 139 repubblicani alla camera e 8 al senato, sono state effettivamente proposte. L’attesa di un voto del congresso sull’invalidazione del suffragio popolare in ben 6 stati (https://www.nytimes.com/2021/01/05/us/politics/republicans-congress-election-certification.html) – ridottisi a due a seguito della carica al parlamento- indipendentemente dalla sua possibilità di successo, ha esaltato gli animi di chi non ha accettato la sconfitta di Trump e ne ha provocato la spettacolare marcia e presa del Campidoglio il giorno della conta e della certificazione dei voti dei grandi elettori. Un assalto costato 5 morti e la caduta nell’immaginario collettivo del mondo intero -che vi ha assistito sbigottito- dell’immagine di democrazia forte e inattaccabile, di cui gli Stati Uniti hanno sempre goduto.
Nonostante il processo di impeachment a Trump, che si svolgerà in ogni caso quando ormai egli non sarà più Presidente, abbia fra i suoi scopi proprio il recupero di quell’immagine agli occhi della pubblica opinione mondiale – oltreché di impedirgli per sempre di assumere incarichi pubblici e di fungere da deterrente nei confronti di chi avesse un giorno l’intenzione di replicarne le gesta- restano, tuttavia, aperti alcuni interrogativi di fondo che la sua presidenza ha posto sul tappeto.
Se Trump ha potuto fare tutto ciò che ha fatto non è forse stato anche in grande misura perché il diritto, con i suoi tanti lati oscuri, glielo ha concesso? Se è così l’impeachment, quand’anche portasse in Senato alla condanna di Trump, non sembrerebbe davvero garanzia sufficiente contro gli straripamenti di un futuro esecutivo che trovasse un contesto a lui più favorevole. Le pieghe opache del tessuto normativo non verrebbero, infatti, cancellate e con esse permarrebbe la possibilità di un rivolgimento anti-democratico del sistema.
Se, però, Trump non è riuscito nell’intento di portare i risvolti oscuri di quel sistema alle loro estreme conseguenze è per via delle controspinte provenienti da chi incarna le istituzioni, rivelatesi capaci di impedire a quegli aspetti antidemocratici di prendere il sopravvento.
Così John Roberts, Chief Justice della SCOTUS, per salvare la legittimazione dell’istituzione che presiede -di fronte a una Corte sbilanciata verso posizioni conservatrici poco rappresentative dell’opinione della maggioranza a causa delle nuove nomine di Trump – quest’estate si è allineato a sorpresa con i progressisti in decisioni importanti in tema di diritti di LBGTQ, di aborto e di immigrazione, in cui ha fatto la differenza (cfr.: https://www.questionegiustizia.it/articolo/un-nuovo-ago-della-bilancia-i-sogni-inconfessabili-di-trump-si-scontrano-con-justice-roberts-e-la-risorta-rule-of-law; http://temi.repubblica.it/micromega-online/usa-no-discriminazioni-a-lbgtq-sul-lavoro-la-corte-suprema-torna-neutrale/)
Analogamente il senso di responsabilità istituzionale, e non il tornaconto politico –che, data l’imponente base elettorale a favore di Trump, avrebbe probabilmente richiesto una mossa diversa – sembra aver giocato nella ferma presa di posizione di quei segretari di Stato e rappresentanti degli Stati a maggioranza repubblicana, che hanno rifiutato di sostituire la lista dei grandi elettori votati dal popolo con una lista nominata dai parlamenti. Una diversa scelta sarebbe stata forse giuridicamente possibile, come ben sapeva Rudy Giuliani, ma a scapito della democrazia e della pace sociale.
Possiamo quindi concludere che il meccanismo delle spinte e delle controspinte, che caratterizza le dinamiche giuridico-istituzionali della vita democratica statunitense, ne assicuri infine e nonostante tutto la stabilità? La risposta appare per il momento positiva, ma altre figure si stanno affacciando sempre più imperiose sulla scena, con forti capacità di alterare pesantemente gli equilibri del gioco. Sono i potentissimi attori privati, guidati da logiche non istituzionali, bensì puramente egoistiche, che oggi censurano Trump sulle loro piattaforme o gli impediscono di usare il proprio sistema di pagamento per la sua campagna, ma che domani ben potrebbero togliere la parola a chiunque altro o colpirlo nella sua capacità di raccogliere fondi, sol che lo ritenessero opportuno per soddisfare i propri interessi. Sono i giganti che agiscono come finanziatori elettorali, senza l’aiuto economico dei quali (almeno dai tempi di Obama, che per primo nel 2008 ha rifiutato i fondi federali che avrebbero comportato un limite di spesa per la sua campagna) nessun politico statunitense può pensare di essere eletto. Ciò anche a causa della nota decisione della SCOTUS del 2010 (Citizen United), che ha consentito alle persone giuridiche di investire sui candidati cifre illimitate, col risultato che grandi multinazionali determinano ormai negli Usa la sconfitta o la vittoria di chi partecipa alle tornate elettorali. Potenze economiche come Marriott, Dow chemical, AT&T, Hallmark, Airb&b, Coca Cola, Blue Cross Blue Shield, Boston Scientific, Commerce Bancshares, grandissime banche come Bank of America o Wells Fargo Bank, titani della finanza come Morgan Stanley o Goldman Sachs, dopo gli eventi del 6 gennaio hanno dichiarato di sanzionare, togliendo loro per il futuro ogni fondo, i 147 repubblicani che hanno sottoscritto le obiezioni alla certificazione dei voti dell’Arizona e della Pennsylvania (https://www.nytimes.com/2021/01/11/business/banks-citigroup-goldman-sachs-politicians.html). Se oggi la sanzione tocca a loro, domani potrebbe toccare a chi in una situazione analoga le obiezioni invece non le sottoscriva. E’ con questi colossi privati, che si stanno mangiando il pubblico insieme alle sue regole e alle sue istituzioni, che la democrazia dovrà fare sempre di più i conti, in Usa come nel mondo intero.
Questo articolo è stato pubblicato su Questione Giustizia il 20 gennaio 2021