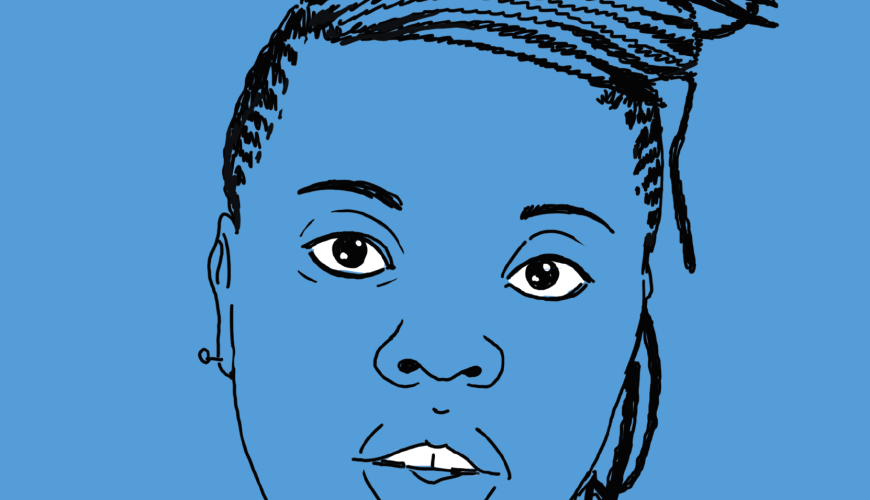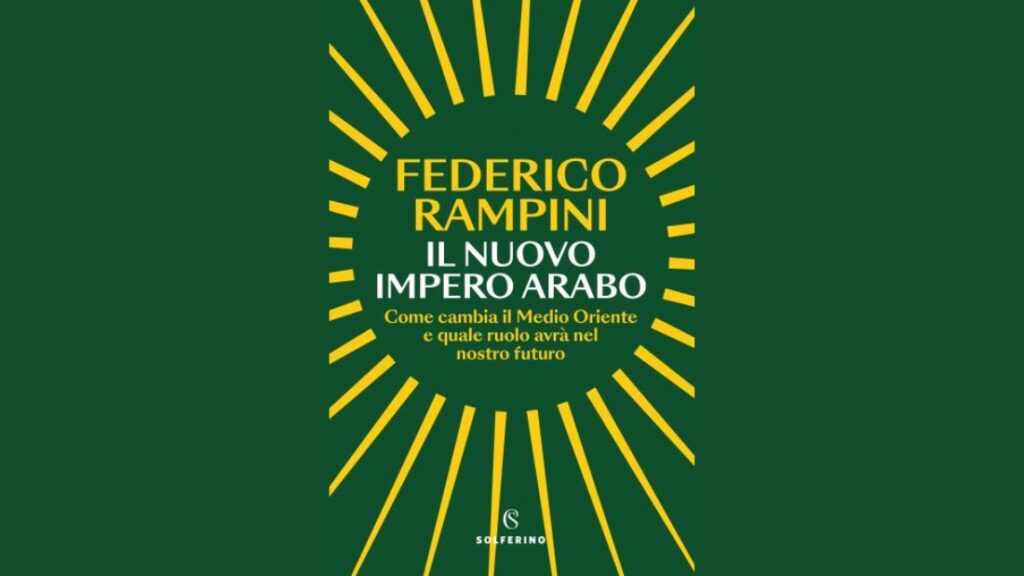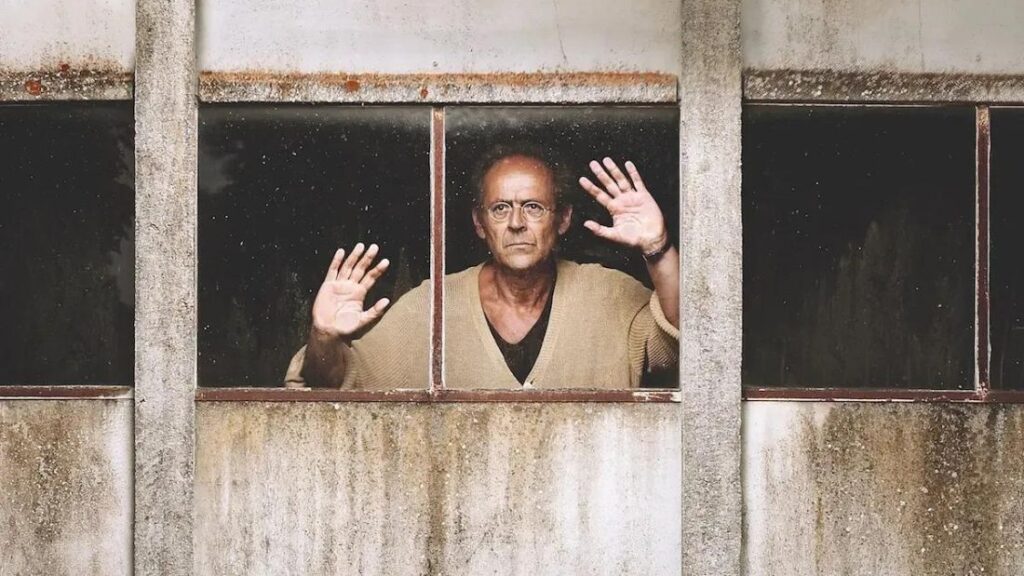di Valeria Ribeiro Corossacz e Tatiana Petrovich
E poi basta. Manifesto di una donna nera italiana di Espérance Hakuzwimana Ripanti (2019, People).
È una lettura necessaria per le persone che vivono in Italia, in particolare per coloro che vivono l’Italia come una società in movimento e in cui agire individualmente e collettivamente per produrre trasformazioni.
Sin dal titolo il libro svela il punto nevralgico della riproduzione del razzismo odierno: la bianchezza come tratto consustanziale all’italianità, un tratto sempre più apertamente rivendicato, e l’esercizio del razzismo come esercizio di potere anche attraverso l’omissione della propria bianchezza quale elemento strutturale della relazione con quei soggetti definiti e trattati come Altri: immigrati, eternamente migranti, stranieri, non-italiani, “seconda generazione”, neri.
Il libro non ha presentazioni di autori più o meno famosi o di studiosi, e la struttura si snoda in macrosezioni (E poi basta, Donna e nera…) e sottosezioni (“Animale da palcoscenico”, “Antirazzista wannabe”…) che raccontano per esperienza e riflessione il funzionamento e gli effetti del razzismo. Narrato in prima persona, E poi basta chiama subito in causa il tu della lettrice/del lettore, dialoga con una persona amata, e opera polifonicamente, con continui rimandi. Gli sguardi e le voci nelle citazioni e nelle epigrafi che aprono il testo spaziano dalla letteratura italiana (Tondelli), alla poesia e alla prosa di autori e autrici africani o della diaspora caraibica, a frammenti del discorso pubblico italiano. Nell’epigrafe iniziale i versi di Love after Love di Derek Walcott evocano il ruolo della scrittura per Hakuzwimana Ripanti, la possibilità di rappresentare un sé complesso, finalmente ricostruito, che esorcizza la “condanna” ad essere solo e soltanto oggetto di lettura (p. 9), o di uno sguardo razzista continuo che causa costante“fatica” e “rabbia”. Nel rievocare la “bambina che sono stata”, “i nostri otto anni”, “i sedici di rabbia”, “i ventuno di fughe e i ventotto che ci hanno visto arrivare” (p. 11-12), la scrittura letteraria di Hakuzwimana Ripanti parla agli altri e racconta di sé, di ciò che ha avuto (“mia madre”, “mio padre e Angela Davis”, “La mia Africa”, p. 55, p. 127, p. 63), e di ciò che è mancato, a lei e alle bambine come lei (“Qualcuno che mi vedesse”, “Qualcuno che mi somigliasse”, pp. 79-80), riparando un’identità frammentata dal razzismo e dal sessismo con un punto di vista fluido e plurale che si muove dentro e fuori di sé, tra passato e presente e tra diversi livelli, in un’inquietante ma verosimile narrazione dell’ordinaria distopia italiana.
E poi basta. Manifesto di una donna nera italiana è un testo stratificato che intreccia analisi sociologica, autobiografia, invenzione e ri-creazione, mette insieme in uno sforzo utopico letteratura e realtà, italiani riconosciuti come tali e persone nate o cresciute in Italia il cui diritto all’esistenza è quotidianamente negato e che quotidianamente resistono, lavorano, creano, semplicemente vivono, e i morti, le persone uccise in Italia perché nere, da Jerry Essan Masslo a Idy Diene (“Corpi”). Testo letterario e insieme “esercizio di memoria” individuale e collettiva, il libro è un Manifesto scritto per essere appropriato da tutte quelle persone, soprattutto donne, che vivono e hanno vissuto esperienze di discriminazione razzista e sessuale, e da tutti coloro che sono capaci di aprire un varco in sé stessi per ripensare cosa sia il razzismo. L’intreccio tra razzismo e sessismo, nello specifico, si traduce nell’esperienza paradossale di essere ipervisibili, oggetto sessuale di uno sguardo costante perché donne nere (“sono nera e quindi prostituta, e quindi disponibile, desiderosa, accessibile”, p. 125), o invisibili perché non bianche. Il razzismo, sottolinea Hakuzwimana Ripanti, non è solo aggressione fisica e verbale (“negra”, p. 109, 114, 212), esclusione sociale e apparato istituzionale. Il razzismo prende corpo anche attraverso un insieme di micro-aggressioni quotidiane, che spesso si materializzano nella battuta, o nelle domande apparentemente innocue fatte anche da persone care, vicine, da amici, fidanzati, da persone convintamente antirazziste.
La domanda ossessiva, quotidiana, è il banale ““di dove sei?””, e l’ulteriore richiesta, “fredda, diretta e senza sconti” che segue alla risposta, valutata come insufficiente (““di un paese in provincia di Flero, italiana, della Lombardia, del Nord Italia””): “Sì, ma di dove sei veramente?”” (p. 41). Quella domanda, apparentemente innocente, scava via ogni giorno un frammento di presenza, riflette il potere invisibile di chi ha “la pelle chiara”, e perciò non si sente mai diverso (p. 10), di riprodurre la bianchezza semplicemente negando l’esistenza di persone nere italiane.
Hakuzwimana Ripanti nomina e racconta l’effetto di questa costante esposizione a micro e macro aggressioni: “qui fuori il mio corpo non è al sicuro”, “se ti scrivo è perché mi sento in pericolo” (p. 119, pp. 15-16). Il punto più complesso che l’autrice affronta è l’incredibile negazione da parte della maggioranza bianca di questa sensazione di pericolo per la propria persona e la mancata possibilità di avere un’individualità per chi è classificato e percepito come nero. A fronte di questa esperienza di pericolo, sono tante le strategie per farvi fronte messe in atto individualmente, e una di queste è rintracciabile nella figura di Anna.
Anna è una compagna di vita immaginaria, ma al contempo realissima nel suo sostenere Hakuzwimana Ripanti, nei momenti più difficili, attraverso tanti piccoli gesti protettivi che però non portano alla resa, bensì alla possibilità psicologica di preservarsi, di difendersi da un mondo che martella, che non lascia un minuto libero, un centimetro di spazio per respirare senza essere oppresse dal razzismo e dal sessismo. Anna è una fase in cui la rabbia esiste e va gestita affinché non distrugga il soggetto che (r)esiste; è grazie ad Anna che l’autrice può finalmente guardare la propria rabbia in faccia e trasformarla in energia positiva e trasformativa. La rabbia, che Hakuzwimana Ripanti sapientemente descrive nel libro come un sentimento che finalmente può essere vissuto e nominato, non si esaurisce nella dimensione psicologica e intima, ma ha un carattere politico, che riguarda tutte e tutti, e diventa un problema per coloro che hanno il privilegio di non vedersi nella loro finta “neutralità”.
La soppressione simbolica della nerezza in Italia e della nerezza italiana di cui racconta Hakuzwimana Ripanti agisce a monte e a valle, a livello simbolico e materiale. La negazione del “semplice” diritto a essere a una persona che sembra “uguale a loro”, “così uguale a loro”, “anche se è evidente che non lo sia” (p. 41) riporta nel presente l’antico dogma del razzismo scientifico e la mutua esclusività tra italianità e nerezza del razzismo coloniale e fascista. L’idea, a monte, che esistano differenze di razza tra esseri umani decide ancora oggi della vita e delle opportunità delle persone. Il colore della pelle costituisce tutt’ora una “diversità” “che non si può nascondere” perché le persone bianche “te la fanno vedere sempre” (p. 115), nonostante la smentita delle scienze dure, o la volontà di non vedere gli effetti di quell’idea di “diversità” in alcune realtà anti-razziste color blind (cfr. 162). E ciò che non si riesce a vedere, ciò che non si è voluto vedere neanche dopo la tentata strage razzista di Luca Traini a Macerata nel febbraio 2018, è che quella sensazione di pericolo continuo di cui parla Hakuzwimana Ripanti è reale, perché la negazione della presenza e del diritto a esistere del corpo nero, quando non rientra nelle categorie decise dal razzismo, è totale e reale, può arrivare, è già arrivata, all’omicidio razzista, come nel caso già citato di Masslo, e delle tante persone nere nominate nel libro.
A fronte di questa esperienza di pericolo, la lettura di testi, che porta la conoscenza di altre esperienze e del nostro passato coloniale e razzista, si presenta come la possibilità di costruire nuove relazioni e nuovi sguardi su se stesse e sul mondo. I libri e lo studio rappresentano una salvezza concreta, ed è questo uno degli aspetti più potenti di E poi basta. Nella pluralità di testi letterari che il libro cita, quasi fosse fagocitata dalla categoria implicitamente razzista e insufficiente della ““Letteratura italiana”” ““della migrazione”” (p. 156), a eccezione di Igiaba Scego, è però assente qualsiasi riferimento alle autrici e agli autori neri italiani, da Antonio Campobasso a Gabriella Ghermandi, Pap Khouma, Ubax Cristina Ali Farah, Antonio Dikele Distefano, ecc.
La voce di Hakuzwimana Ripanti, tagliente e necessaria, racconta come coloro che sono oppressi dal razzismo e dal razzismo insieme al sessismo (“quanto fai per un pompino?”, p. 125) non hanno diritto all’individualità, e di come invece questa individualità esista, resista e reagisca ai soprusi. “L’Italia non mi dà alternative: o sono una sportiva, o canto benissimo, o mi prostituisco” (p. 125). Nel nominare la propria individualità c’è anche la pratica stessa di una analisi femminista intersezionale: “Sono nera, italiana, donna, e scrivo. Quando penso a me, alla mia persona, non so e non so riconoscere quale aggettivo tra queste definizioni sarebbe più importante mettere prima e quale dopo. Perché oltre a essere nera, italiana, donna e scrittrice, sono anche giovane, e innamorata, stanca di tante cose…”. (p. 151).
Proprio entrando nelle pieghe di come si nega l’individualità degli oppressi, schiacciati in un’unica grande categoria che è quella del gruppo a cui si è deciso di farli appartenere, Hakuzimana Ripanti ricorda che non tutti i neri vogliono essere attivisti: “Io non volevo fare l’attivista”. La libertà di non doversi organizzare per difendere la propria vita, la propria persona e individualità rimane un privilegio di coloro che appartengono al gruppo sociale dei bianchi.
Questa lettura attenta dei meccanismi del razzismo, e della sua riproduzione diffusa, ci sembra in dissonanza con l’idea presente nel testo (p. 126, 128, 167) che l’ignoranza sia un elemento compartecipe della sua produzione. Al contrario, nel razzismo, anche nel suo intreccio con il sessismo, è all’opera una conoscenza, un sapere, già prima dell’incontro individuale, un sapere sedimentato da tempo, prodotto dalla storia di colonialismo e razzismo, e che mette in gabbia gli Altri, le singole individualità. Leggere questo libro aiuta del resto a capire come il carattere naturale del razzismo venga costruito attraverso un processo che vede i corpi isolati dai rapporti sociali, e precedenti ad essi, che li sottrae alla storia. “I neri puzzano” (p. 212), l’odore dei neri, il corpo dei neri (“sembri una scimmia”, p. 113) è un elemento ricorrente del razzismo e di altre esclusioni, se pensiamo alla diffusa percezione dell’odore come tratto distintivo di posizioni sociali diseguali, così come l’idea che i neri, o altri gruppi minoritari, portino malattie: “Ehi, senti, ma non è che hai l’Aids o cose del genere? Visto che sei dell’Africa, sai, vorrei essere sicuro” (p. 214). Questa frase, con cui l’autrice ha dovuto fare i conti, è un esempio del modus operandi del razzismo, del modo in cui si trasforma una patologia, un virus, in un tratto connaturato a un corpo, in cui le pratiche sociali, i condizionamenti prodotti dalla storia e le responsabilità sono cancellati. A fronte di questo processo di naturalizzazione delle oppressioni e di percezione in termini razziali dei virus e della loro natura immaginata più che conosciuta, la nostra risposta deve depatologizzare i comportamenti razzisti ricorrendo a letture più fini, complesse e liberatorie, come quella proposta da Hakuzwimana Ripanti.
Il libro si chiude con una sezione preceduta da un’epigrafe tratta da Una lirica americana (2017) di Claudia Rankine, scrittrice giamaicana che vive negli Stati Uniti e ha indagato sul funzionamento del razzismo attraverso la sovraesposizione, la negazione o l’eliminazione della nerezza. “Corpi”, un elenco di brevi trafiletti tratti dalla cronaca recente, relativa al 2018, porta alla luce il fattore scatenante di atti di violenza apparentemente insensati, o irrazionali, come il colpo di pistola esploso da un uomo italiano di 59 anni che ha paralizzato una bambina rom di 14 mesi (p. 207): la percezione e la traduzione in azione, da parte delle persone bianche, delle persone non bianche come persone uccidibili in sé.
Questo articolo è stato pubblicato su Il lavoro culturale il 12 maggio 2020