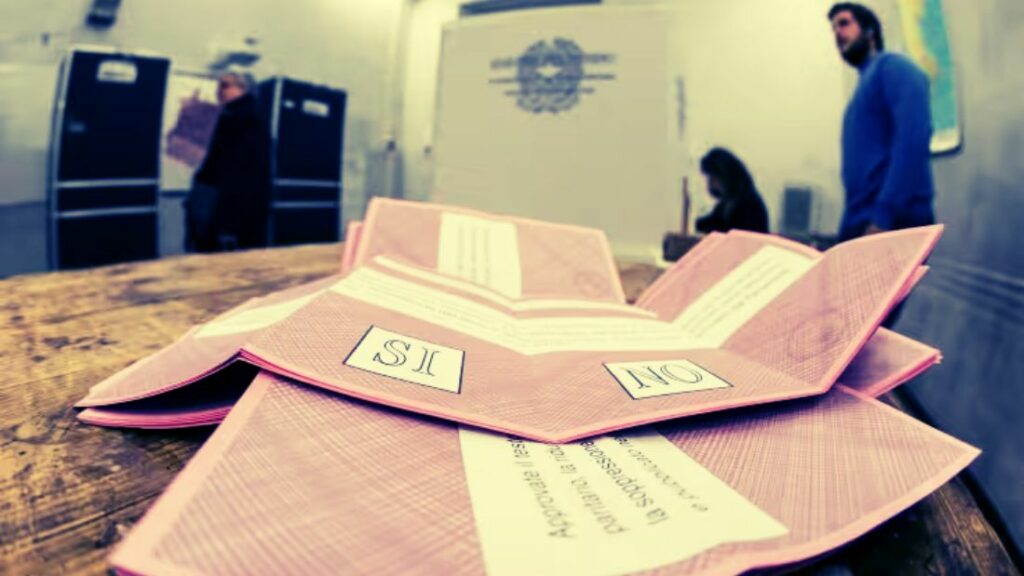di Gianfranco Pasquino
Leggo periodicamente le grida di dolore emesse da coloro che hanno sonoramente perso il referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Sono accompagnate da indignate invettive contro i professoroni e soprattutto contro Gustavo Zagrebelsky. Avremmo, non rispondo a nome suo, ma mi prendo la mia parte di responsabilità, aperto la strada a infinite (non ancora finite) nefandezze di fronte alle quali staremmo tutti zitti mentre il governo Lega-5 Stelle è affaccendato nella distruzione della Costituzione “più bella del mondo”.
Sull’aggettivo “bella” ho già eccepito poiché non esiste un concorso di bellezza per le Costituzioni che sarebbe comunque vinto dalla Costituzione mai scritta, quella del Regno un tempo Unito. Dopodiché, contrariamente agli scrittori di stupidaggini seriali sul referendum, sulla Costituzione e sul governo, entro nel merito.
Davvero il governo giallo-verde è il prodotto inevitabile della sconfitta di Renzi nel referendum? Molti cadono nella fallacia del post hoc ergo propter hoc sostenendo che un evento del dicembre 2016 ha determinato un evento del marzo 2018. In quindici mesi, il Partito Democratico e il suo segretario non sono riusciti a recuperare abbastanza voti per rendere quel governo impraticabile. Se qualcuno continua a sostenere che il 40 per cento di Sì erano voti di Renzi, allora ha già deragliato. Inconsapevolmente segnala il più gigantesco degli errori di Renzi: avere trasformato un referendum sul pacchetto di riforme in un plebiscito sulla sua persona. Ai plebisciti su persone, i democratici hanno l’obbligo di rispondere sempre e senza esitazioni: No.
I sostenitori della tesi che il No ha prodotto il governo giallo-verde dicono un’altra cosa grave. La campagna elettorale del Pd, maldestramente guidata dal suo segretario, che non voleva che crescessero prestigio e apprezzamento per Gentiloni capo del governo, non ha saputo recuperare neanche un voto. Se la comparazione è con Bersani 2013, ha perso il 7 per cento degli elettori, molto più di coloro che hanno votato LeU. I renziani dimenticano ad arte che la coalizione 5 Stelle-Lega non era l’unica possibile. Cinque Stelle e Partito Democratico avevano la maggioranza assoluta di seggi sia alla Camera sia al Senato. La prematura e dissennata decisione di Renzi di buttare il suo partito all’opposizione ha reso quasi inevitabile il governo Di Maio-Salvini. Questo governo è preferibile ad un governo Cinque Stelle-Pd? Un partito che dichiara di avere una missione nazionale accetta, senza neppure un dibattito interno e senza esperire le alternative possibili, di andare all’opposizione? Per starci, poi senza saperla fare, rivelandosi irrilevante, paralizzato dal suo due volte ex-segretario e dai parlamentari da lui nominati, maggioritari nei gruppi Pd sia alla Camera sia, ancor più, al Senato.
Adesso, 5 Stelle e Lega stanno manomettendo la Costituzione e né Zagrebelsky né i professoroni (quelli schedati da due politologi renziani per screditarli con riferimento all’età e alle cariche ed onori) si attivano per difenderla. Non discuto delle autonomie regionali differenziate. Vado sulle due riforme costituzionali già iniziate: referendum propositivo e riduzione del numero dei parlamentari. Sul primo, ricordo che la riforma costituzionale renziana andava nella direzione di dare maggiore potere ai referendari. Esistono notevoli differenze, ma il punto riguarda le modalità di legiferare. I Cinque Stelle vogliono trasferire potere ai cittadini a scapito del Parlamento. In realtà, potrebbe risultare che il referendum propositivo toglie potere al governo piuttosto che al Parlamento e che parlamentari competenti saprebbero come ridefinire i compiti delle rispettive Camere riconquistando le funzioni più importanti: controllo sull’operato del governo, conciliazione di interessi, comunicazione con la cittadinanza e rappresentanza politica.
La riduzione del numero dei parlamentari voluta dalle 5 Stelle ha le più classiche motivazioni populiste: tagliare “poltrone” per ridurre i costi, passando da 630 deputati a 400 e da 315 senatori eletti a 200 (in totale da 945 a 600 eletti) sembra essere il vero punctum dolens. La trasformazione del Senato secondo la riforma Renzi eliminava i Senatori eletti dai cittadini, recuperandone 95 dai Consigli regionali più cinque senatori a vita, veri “cavoli a merenda”. Da 945 parlamentari eletti si scendeva a 630 più 100, con la motivazione populista (e un di più di decisionismo accattone): meno poltrone, meno costi, i senatori di provenienza regionale non avrebbero avuto indennità, ma solo rimborso spese. Però, la rappresentanza politica non è mai solo faccenda di numeri. Dipende dalle modalità con le quali i rappresentanti sono eletti e possono essere rieletti. Da questo punto di vista, il colpo mortale alla rappresentanza politica viene, da un lato, dall’eventuale, ancorché fondamentalmente impossibile da praticare, vincolo di mandato, dall’altro dai limiti ai mandati elettivi.
La Legge Rosato con le sue liste bloccate è fatta per rendere impossibile la buona rappresentanza politica. Gli eletti sanno di dovere la loro “poltrona”, non agli elettori di fronte ai quali non avranno nessun incentivo a tornare per parlare di politica spiegando quel che hanno fatto, non fatto, fatto male, ma a chi li ha messi in lista in posizioni eleggibili. Il ministro Boschi annunciò che i capilista bloccati (paracadutati, come lei stessa sarebbe stata a Bolzano nel 2018), nominati dal segretario del partito, diventavano “rappresentanti del collegio”.
Obiettai che sarebbero stati i commissari politici di quel segretario. La combinazione della riforma del Senato, con i nuovi senatori a rappresentare non i cittadini delle rispettive regioni, ma i partiti di quelle regioni e il suo depotenziamento quanto a rappresentanza e capacità di controllo sull’operato anche legislativo del governo, con la legge elettorale, Italicum o Rosato, incideva gravemente sulla rappresentanza politica. Con un’alzata di spalle, i renziani unitamente a commentatori politici, giornalisti e politologi, raccontarono la favola del trade-off: rinunciare a un po’ di rappresentanza per avere un tot di governabilità (garantita da un cospicuo premio di seggi). Alla faccia di coloro che pensano, con notevoli pezze d’appoggio, che una ampia e diversificata rappresentanza politica è premessa e fondamento irrinunciabile di qualsiasi governabilità.
No, la riduzione del numero dei parlamentari, magari giustificata con la necessità di maggiore e migliore efficienza, da un lato, non è di per sé un attentato alla democrazia, dall’altro, però, esige una apposita legge elettorale di cui non v’è traccia nel disegno riformatore del governo giallo-verde. Le critiche dei renziani e dei sostenitori delle riforme sconfitte sono opportunistiche e inaccettabili. Le riforme delle 5 Stelle si muovono sul loro stesso terreno. Sono contrastabili con le argomentazioni usate dai sostenitori del No. Lo saranno se e quando diventerà necessario. Lo farò insieme ai moltissimi “partigiani cattivi”. Nel frattempo, mi auguro, senza farmi illusioni, che i produttori seriali di stupidaggini costituzionali imparino qualcosa.
Questo articolo è stato pubblicato dal Fatto Quotidiano il 25 luglio 2019