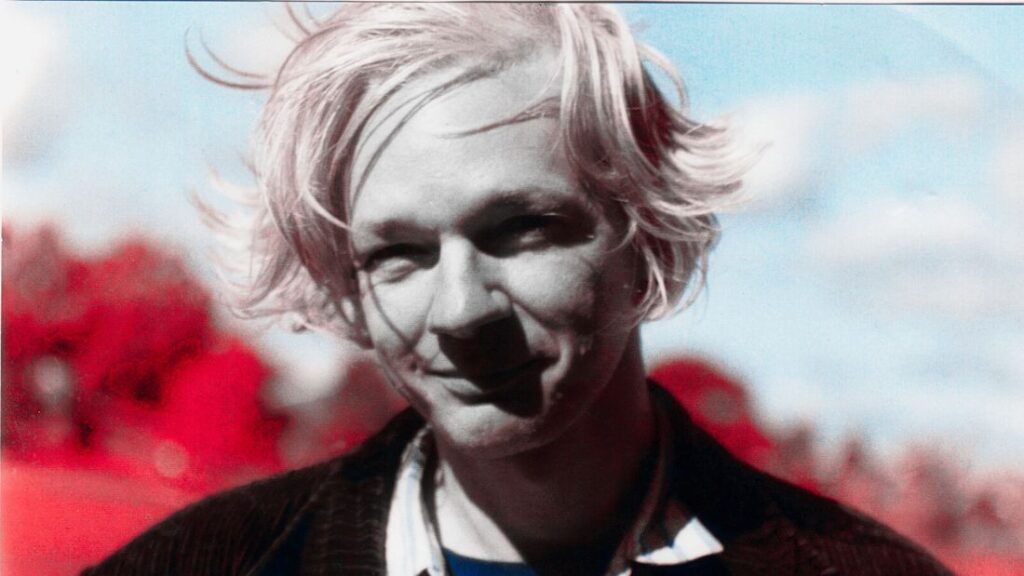di Loris Campetti
L’ultimo corpo senza vita, il “numero” 296, trovato sotto le macerie di Amatrice apparteneva a Sayed. Era un ragazzo diventato amico di tutti, un rifugiato afgano che viveva, nella casa che gli è crollata addosso, insieme a Sultan, Whaid, Adil: loro per fortuna si sono salvati, fuggiti prima del crollo oppure proiettati fuori casa dalla violenza della scossa.
Sayed doveva partire per Torino dove aveva trovato lavoro come pizzaiolo, ma aveva rinviato la partenza di qualche giorno per partecipare alla festa degli spaghetti all’amatriciana. Di un albanese e 11 romeni sono stati recuperati i corpi dai soccorritori quando per loro, ormai, era troppo tardi. Il terremoto non fa distinzione tra indigeni e stranieri, colpisce dove e chi capita anche se a uccidere, come ha detto il vescovo di Rieti Domenico Pompili ai funerali ad Amatrice, non è il terremoto ma sono le opere dell’uomo.
Le opere fatte, quelle non fatte, quelle malfatte. Immigrati sotto le macerie e immigrati a scavare tra le macerie per salvare qualche vita. Abdullai del Benin con altri 17 migranti è andato a dare una mano ad Arquata del Tronto, ad Amatrice a scavare è un gruppo di richiedenti asilo ospitati nel paese colpito come Sayed. I profughi di Monteprandone sono partiti per Amandola per ripulire un campo destinato a ospitare i soccorsi. I migranti in attesa di asilo in Val Candina, Avellino, si sono aggregati a una colonna della Protezione civile in partenza per l’Appennino marchigiano.
Settantacinque migranti di Gioiosa Ionica, in Calabria, hanno deciso di devolvere in favore degli sfollati i pocket money, la paghetta data loro nei centri di accoglienza. I cinesi che da tempo vivono a Prato e Firenze e lavorano (spesso come schiavi) nel tessile hanno promosso una raccolta di fondi per le popolazioni colpite dal sisma.
Volontari provenienti da tutt’Italia insieme alla Protezione civile e ai Vigili del fuoco rappresentano la parte sana del paese, scavano e non chiedono a chi da giorni sta sotto le macerie il luogo di nascita. Anche il labrador Leo, quello accarezzato da Merkel e Renzi, non ha chiesto la nazionalità alla bambina Giorgia prima di consentirne il salvataggio.
Ma c’è un’altra Italia, purtroppo, ben peggiore del popolo multietnico della solidarietà e anche del cane Leo ma per fortuna più piccola. I professionisti dell’odio xenofobo non hanno perso un solo giorno per scatenarsi contro “lo straniero”. Libero, giornale maestro d’odio, ha lanciato una campagna subito raccolta dal leghista Salvini per cacciare i richiedenti asilo dagli alberghi della costa adriatica sostituendoli con i terremotati; Bertolaso, l’anima nera del terremoto dell’Aquila con cui per fortuna i nuovi sfollati non avranno a che fare, spera che ci siano abbastanza tende per i terremotati e non siano state tutte impiegate per i migranti; il presidente della Lombardia Maroni vuole che nel campo base dell’Expo destinato ai migranti siano invece collocati i terremotati. I quali non sperano altro che abbandonare terra, averi e lavoro per andare sotto una tenda alla periferia di Milano.
Ma finché avremo un po’ di umanità eviteremo di augurare ai professionisti dell’odio quel che è capitato ai terremotati e quel che capita, ogni giorno, a chi fugge da guerre dittature e fame alla ricerca di un pezzetto di futuro.
I paesi sperduti dell’Appennino, spina dorsale dell’Italia, si stanno spopolando. In molti casi a tenerli in vita sono i migranti, come in alcune realtà della Calabria rianimate dai kurdi, o negli stessi Sibillini dove da anni a occuparsi di pascolo, mungitura e tosatura delle pecore, sono pastori romeni e macedoni: nelle forme di pecorino c’è la mano di lavoratori stranieri. Sarebbe logico legare la gestione dell’immigrazione alla necessità di ripopolamento e cura dei nostri Appennini. Sarebbe anche un modo per disarmare i Salvini, i Maroni, i Bertolaso.
Questo articolo è stato pubblicato sulla rivista Area>/a>