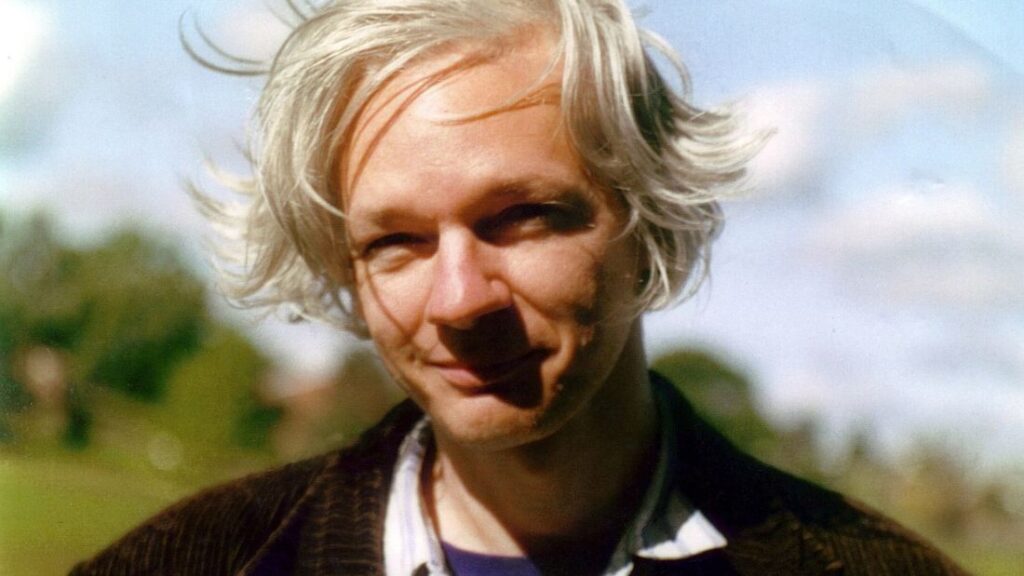di Corriere Immigrazione
«Da anni i richiedenti asilo in Italia vivono troppo spesso una situazione paradossale: dopo avere ottenuto lo status di rifugiati o, comunque, la protezione internazionale, vengono abbandonati a loro stessi senza poter accedere a reali percorsi di integrazione. La conseguenza inevitabile di questa grave mancanza, soprattutto nelle aree metropolitane, è il generarsi di circuiti spontanei di “accoglienza”: tendopoli, baraccopoli, edifici abbandonati, quando non addirittura la strada». Esordisce in questo modo Alberto Barbieri.
Medu, l’associazione di cui è coordinatore generale, non riferisce queste cose per sentito dire. Da molti anni ormai, tra i suoi impegni, c’è quello di portare l’assistenza sanitaria nei cosiddetti circuiti spontanei d’accoglienza. «È un dato su cui riflettere», prosegue, «che il 40% delle persone senza dimora assistite dalle nostre unità mobili, a Roma e Firenze, nel corso del 2011, fosse costituito da richiedenti asilo, rifugiati e profughi in transito verso altri paesi europei. Giovani uomini ma anche donne, ragazzi e bambini: il nostro paziente più piccolo aveva 4 anni e veniva dall’Afghanistan. Passava le sue giornate tra il marciapiede e una misera tenda alla stazione Ostiense, nel centro di Roma».
Ma, accanto a questo paradosso, lei ne segnala un altro, forse ancora più allarmante.
«Sì, il paradosso nel paradosso è che un problema ormai evidentemente “endemico”, di cui istituzioni e medi dovrebbero essere ben coscienti, continui a essere affrontato e riproposto all’opinione pubblica quasi esclusivamente nella dimensione dell’emergenza, per poi essere rimosso fino a un nuovo evento in grado di suscitare un qualche clamore. È inevitabile qui il riferimento alla situazione degli oltre 17.000 profughi accolti nell’ambito della cosiddetta emergenza Nord Africa, conclusasi ufficialmente il 31 dicembre, che stavano per trovarsi per strada a gennaio e per i quali è stata disposta una breve proroga dell’accoglienza (appena 2 mesi) solo pochi giorni prima dello scadere dell’anno».
Volgendo lo sguardo al passato, di paradossi nel paradosso ne troviamo molti altri…
«Certamente. Oltre al caso dell’ex-ambasciata somala, e solo per citare gli episodi più recenti di cui siamo stati testimoni, si può ricordare la vicenda dei rifugiati afgani costretti a vivere per anni in condizioni disumane presso la Stazione Ostiense balzata all’attenzione delle cronache, e poi delle istituzioni, solo quando la crisi ha raggiunto estremi speleologici o metereologici: “i bambini afgani dormono dentro i tombini”, “i rifugiati sono accampati in una buca”, “la tendopoli sotto la neve”. Finalmente, a febbraio dello scorso anno, i rifugiati dell’Ostiense hanno trovato accoglienza con standard minimi presso una struttura provvisoria approntata a Tor Marancia dal Comune. Anche in questo caso però è lecito supporre che la soluzione sia arrivata solo grazie ad “un imprevisto”. La tendopoli dei rifugiati si trovava infatti proprio nell’area in cui era necessario far posto con urgenza al cantiere di una nuova stazione dei treni ad alta velocità. Oppure si può ricordare il fatiscente edificio di via Guidoni a Firenze che ospitava in condizioni drammatiche circa 150 rifugiati somali e di cui le istituzioni si occuparono solo in seguito all’incendio che divampò a natale del 2009».
C’è una situazione che riflette in modo particolare le criticità del sistema di accoglienza italiano?
«Direi che quella romana è uno specchio esemplare. Roma ospita il maggior numero di rifugiati in Italia. Nell’area metropolitana sono oltre 1.500 i rifugiati, richiedenti asilo e profughi, che vivono per strada, in tende, baraccopoli o in edifici precari. Se l’esclusione e la ghettizzazione dei rifugiati rappresentano una degenerazione patologica della nostra convivenza civile, ognuno degli insediamenti spontanei della città esprime uno stadio progressivo di questa “malattia”. L’acuzie è nelle grandi stazioni, Termini e Ostiense, dove profughi arrivati da poco in città vivono letteralmente sulla strada. La fase cronica possiamo vederla invece nella baraccopoli dei rifugiati eritrei a Ponte Mammolo, nei grandi edifici occupati da profughi del Corno d’Africa e del Sudan come il Salaam Palace o sulla Via Collatina, oppure al Centro Ararat di Testaccio dove si trovano i rifugiati curdi. Micro mondi per i quali, dopo anni di assenza da parte delle istituzioni, è ovviamente più difficile trovare soluzioni adeguate. Alla fine del 2011, a fronte di 1.600 persone accolte, erano 1.371 i rifugiati in lista d’attesa per entrare nei centri di accoglienza del circuito comunale, con tempi medi di attesa di 3-4 mesi. Oltre 300 dei rifugiati accolti presentava fragilità sanitarie sia di tipo psichico che fisico. Molti di essi erano stati torturati nel proprio paese. Il sistema di accoglienza cittadino non prevede però posti dedicati a persone con queste particolari vulnerabilità, mentre il sistema Sprar ne ha a disposizione solo sei in tutta Roma. La storia di Aref – profugo afgano, senza dimora e con gravi problemi psichici – è a questo proposito esemplare. Gli operatori di Medu hanno impiegato mesi per riuscire a farlo entrare in un centro di accoglienza perché non si trovava nessuna struttura cittadina disposta ad accoglierlo. Sulla sua cartella clinica si sarebbe potuto scrivere: troppo fragile per poter essere accolto. Per poter poi accedere alla commissione territoriale che esaminerà la richiesta di protezione internazionale, un richiedente asilo che si trovi a Roma deve attendere in media 9 mesi».
La condizione di esclusione si ripercuote anche sulla salute e sulle possibilità di accesso alle cure?
«Certamente ed è inevitabile che sia così. La maggior parte delle malattie dei rifugiati in condizioni di precarietà (infezioni respiratorie e della pelle, disturbi psichici) sono causate dallo stress e dalle pessime condizioni abitative ed igienico-sanitarie in cui sono costretti a vivere. Dei pazienti rifugiati visitati da Medu nella tendopoli di Ostiense, quasi il 40% non era iscritto al Servizio sanitario nazionale, pur avendone diritto, e l’80% non aveva mai usufruito del medico di base. A Firenze poi, per i rifugiati costretti a sopravvivere in edifici fatiscenti come l’ex ospedale Meyer, è difficile addirittura ottenere la residenza e poter così usufruire dei fondamentali diritti sociali tra cui la possibilità di iscriversi al Servizio sanitario nazionale».
Tralasciando le considerazioni politiche, qual è l’intoppo tecnico che produce tutto questo?
«L’Italia è diventata una terra d’asilo per chi, in fuga da guerre e persecuzioni, volge lo sguardo verso l’Europa, questo è un dato obiettivo. A partire dalla fine degli anni novanta l’andamento delle richieste di asilo è progressivamente aumentato avvicinando l’Italia ai paesi europei con maggiore tradizione di protezione internazionale. A fronte di questa tendenza, è andato gradualmente crescendo il gap strutturale tra il numero di rifugiati che giungono nel nostro Paese e il numero di posti disponibili nel sistema di accoglienza e nei servizi di integrazione. Per dare un’idea: alle fine del 2011 vi erano ben 7.431 rifugiati in lista d’attesa per entrare nei progetti di accoglienza dello Sprar, il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. È ovvio che affinché un sistema d’asilo funzioni realmente non è solo necessario il riconoscimento dello status di protezione internazionale, ma anche la messa in atto di un adeguato sistema di prima e seconda accoglienza e di servizi di integrazione che favoriscano l’apprendimento della lingua, l’inserimento lavorativo, l’accesso ad un alloggio e all’assistenza sanitaria».
Ma l’Italia, specialmente in un momento di crisi economica come l’attuale, può permetterselo?
«La risposta non può che essere affermativa, sia dal punto di vista delle risorse economiche e organizzative da mettere in campo sia dal punto di vista dell’imperativo etico di una società democratica e civile. Sebbene in Italia i richiedenti asilo siano progressivamente aumentati nel corso degli ultimi anni, il loro numero assoluto e relativo è ancora sensibilmente inferiore a quello degli altri principali paesi europei. Se la Germania è in grado di accogliere 570.000 rifugiati, la Francia 210.000 e il Regno Unito 194.000, non si vede perché l’Italia non possa dare un’accoglienza dignitosa a poco più di 60.000 rifugiati. La capacità poi di dare protezione alle persone più vulnerabili, e in particolare a coloro che chiedono asilo a causa della violenza e delle persecuzioni subite nel proprio paese di origine, oltre a essere sancito dalla nostra Costituzione e da convenzioni internazionali cui l’Italia aderisce, è un elemento qualificante del grado di civiltà di un’intera collettività che in nessun momento può essere accantonato. Il rischio, in questo caso, è che anche il diritto d’asilo cada definitivamente in quello che Stefano Rodotà ha definito il “deserto dei diritti” riferendosi alla regressione culturale e politica che ha consumato l’Italia negli ultimi vent’anni».
Il sistema attualmente in vigore è del tutto fallimentare?
«Bisogna riconoscere che non tutto è un fallimento, non tutto è rimasto immobile rispetto a quando, nel 2004, un primo articolo del Nyt intitolava Somali Refugees Find a New Kind of Hardship in Italy. Nel 2011, il tasso di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria nel nostro Paese è stato del 40%, un valore superiore alla media europea anche se i tempi di attesa sono spesso inaccettabilmente lunghi. Dopo la sentenza della Corte europea dei diritti umani che ha condannato l’Italia nel cosiddetto caso Hirsi, gli sciagurati respingimenti collettivi di migranti nelle acque del canale di Sicilia non sono più un opzione percorribile, anche se il tratto di Adriatico che separa la Grecia dall’Italia continua ad essere una sorta di “ultimo guado infernale” che molti migranti forzati, soprattutto dall’Afghanistan, sono obbligati ad affrontare al termine di un drammatico viaggio. Il sistema dello Sprar, costituito da una rete di enti locali che – con fondi pubblici e la collaborazione del terzo settore – garantisce da undici anni interventi di “accoglienza integrata”, rappresenta un’esperienza virtuosa che deve essere strategicamente rafforzata. In questo senso il recente decreto del Viminale che aumenta di 700, i tremila posti a disposizione dello Sprar, è un passo positivo, ma di certo non sufficiente, dal momento che il sistema permane gravemente sottodimensionato rispetto alle necessità. Alcune esperienze locali, come ad esempio quella con gli afgani a Roma, dimostrano che è possibile dare un’assistenza dignitosa anche a profughi in transito verso altri paesi europei».
Cosa sarebbe necessario per cambiare?
«Ci vogliono più risorse, più pianificazione, più coordinamento. Su questo convergono tutti i soggetti che hanno avuto a che fare con il sistema asilo. Certamente sono necessarie più risorse per potenziare il sistema e disporre di più posti sia per l’accoglienza ordinaria sia per i rifugiati vulnerabili. Ma altrettanto impellente è la necessità di un “balzo culturale” che porti al superamento della logica dell’emergenza e dell’improvvisazione per approdare a una pianificazione strategica dell’accoglienza dei rifugiati. Una programmazione che contempli anche la gestione di flussi straordinari, diventati negli ultimi anni più frequenti e comunque ragionevolmente prevedibili. È poi indispensabile approdare ad un unico e coerente sistema d’asilo valorizzando esperienze come quelle dello Sprar e superando l’attuale diversificazione del sistema di accoglienza, oggi frammentato in una pluralità di strutture e servizi dagli standard non omogenei e, a volte, neppure comunicanti tra di loro. Un panorama per molti versi caotico, popolato di sigle che sembrano diventare una lingua a se stante: centri Sprar, Cara ovvero centri di accoglienza per richiedenti asilo, Cda ovvero centri di accoglienza, centri polifunzionali, centri di accoglienza dei Comuni e, negli ultimi due anni, i centri gestiti dalla Protezione Civile per l’emergenza Nord Africa. E proprio tornando al caso dall’emergenza Nord Africa, non si può non constatare che malgrado lo stanziamento di ingenti risorse – 1.292 milioni di euro, dei quali poco meno di 600 destinati direttamente all’assistenza dei profughi – i servizi di accoglienza si sono dimostrati fortemente disomogenei (in un caso su quattro sono state addirittura utilizzate strutture alberghiere prive di qualsiasi specifica competenza) e gravemente carenti in molte regioni italiane».
Se la diagnosi è nota e la cura si conosce con ragionevole certezza, perché allora l’Italia non supera il suo paradosso con i rifugiati?
«La crisi economica, per le ragioni esposte, non è un valido motivo. Forse in questi anni nell’opinione pubblica non è maturata una sufficiente sensibilità su questo tema anche a causa di un’informazione carente e di una propaganda politica fuorviante. Con ogni probabilità, nei governi che si sono succeduti in un decennio, sono mancati i presupposti per affrontare con incisività il fenomeno: consapevolezza del problema, volontà riformatrice, adeguate competenze, e la forza politica necessaria. Il 2013 potrebbe essere per l’Italia un anno di cambiamenti politici e sociali profondi, in cui questi presupposti si diano tutti allo stesso tempo e ci sia finalmente una svolta nelle politiche sul diritto d’asilo e più in generale sui diritti umani. In questo senso l’agenda diritti non può essere assolutamente esclusa dal dibattito elettorale. L’auspicio è che non siano più necessari un articolo del New York Times o la morte di Zaher – 13 anni, dall’Afghanistan – schiacciato sotto un Tir in un porto adriatico mentre cerca di entrare di nascosto in Italia, a fare luce, per qualche giorno, sulla condizione di troppi rifugiati in Italia».